dic152009

Qualche giorno fa, per caso, ho scoperto un tesoro. Uno di quei link postati su Facebook da qualche amico, un click a mia volta e si è aperto un mondo: Luigi Paoli in arte Gigetto da Noha. Si tratta di un cantautore di musica popolare salentina, oggi settantaquattrenne, originario di Noha ma stabilitosi a Spongano.
La sua figura mi ha colpito particolarmente. E' un artista ibrido che unisce in sè due filoni della musica popolare salentina: il folk cittadino e il canto contadino.
Fisarmonicista, interprete di brani della tradizione, autore di nuovi testi e nuove musiche. Popolare anche fuori dal Salento, in altre regioni ma soprattutto fra gli emigrati, anche all'estero. La sua produzione ha avuto la tipica distribuzione tramite bancarella, destinata a un pubblico indistinto, non specificamente colto e questo lo sentiamo molto negli arrangiamenti folkeggianti. Ma c'è qualcosa di profondo in quest'artista che è legato a quantu vissuto in prima persona senza quel filtro "intellettuale" che oggi ci contraddistingue. Nasce contadino. Vive la campagna e l'emigrazione da contadino con la famiglia. Impara a cantare il repertorio e lo stile della campagna. Nel tempo libero impara la fisarmonica, un mondo diverso che lo avvicina al filone folk. Emigra anche all'estero, poi rientra. Lavora come cantautore in contatto con dei discografici calabresi (e si sente da alcuni dei suoi testi a da alcuni aspetti stilistici delle sue tarantelle).
Insomma vive tante esperienze diverse che formano e influenzano il suo modo di suonare e cantare per cui la sua produzione è abbastanza varia e variegata. Può piacere tutta o in parte, o può non piacere per nulla..ma merita qualche attenzione.
Personalmente mi entusiasma il suo modo di cantare "contadino", la disinvoltura, oggi rarissima, con cui ricorre al quardo grado aumentato del modo lidio, la sapienza tecnica e il modo di dosare gli abbellimenti come i glissando, i melismi, le esclamazioni, le urla, la sua capacità (un tempo diffusissima e ancora una volta oggi rarissima) di ricorrere agli slittamenti ritmici nel cantare la pizzica (off beat), il timbro vocale assolutamente contadino e il ricorso talvolta a note non temperate.
Insomma, per queste doti, Luigi Paoli entra a pieno titolo fra gli alberi del canto salentini, al pari di tanti cantori che non hanno fatto la "carriera" di cantautori ma con i quali condivide la freschezza del suo stile di canto.
C'è anche un'altro aspetto che ai miei occhi lo rende speciale. Diversamente da quello che la maggiorparte della riproposta contemporanea ha fatto e continua a fare, Luigi Paoli ha fanno innovazione nel patrimonio popolare inventando testi nuovi su arie popolari esistenti..cosa che sembra fosse un tempo il modo naturale di far evolvere la musica tradizionale. Oggi si tende invece a cristallizzare dei testi, cantarli sempre nello stesso modo o reinventare la musica, anche allontanandosi dai moduli della tradizione. Anche per questo Gigetto merita di essere ascoltato, in quanto rappresenta una interessante strada alternativa.
Di tutte le informazioni che in pochi giorni sono riuscito a raccogliere su Luigi Paoli, e degli ascolti che ho potuto fare sulla fantastica piattaforma che è Youtube, devo assolutamente ringraziare Alfredo Romano, salentino che vive nel Lazio e che ha pubblicato vari libri legati alle tradizioni del Salento. Grazie al suo canale su YouTube è possibile ascoltare quasi tutta la vasta produzione discografica di Gigetto da Noha (e se si ha la curiosità di esplorare, si possono ascoltare interessanti registrazioni sul campo dell'area di Collemeto da cui Alfredo Romano proviene). Da questa vasta produzione, vorrei estrarre solo pochi esempi che testimoniano la bravura di Luigi Paoli (sulla base degli elementi che ho elencato sopra). C'è da ascoltare per ore se se ne ha voglia!
Tarantella dellu nsartu (bellissima e da questa si possono ascoltare tante altre pizziche)
http://www.youtube.com/watch?v=p0VBWrj0NWA
Lu pipirussu maru
http://www.youtube.com/watch?v=Ph4x7IaKZvU
Lu trainieri (canto di trainiere)
http://www.youtube.com/watch?v=Sm64_fWrrng
Stornelli
http://www.youtube.com/watch?v=CZwjTP67eZc
Sempre grazie alla gentilezza di Alfredo Romano, è stato possibile reperire e ripubblicare quest'articolo, pubblicato originariamente su "Il Corriere Nuovo di Galatina" nel 1983, in cui lo stesso Alfredo parla del suo incontro/intervista a Luigi Paoli avvenuto in quel periodo. Buona lettura.
march
*********************
Civita Castellana, 17-8-1983
Caro Carlo[1],
ti spedisco un lavoro su Luigi Paoli, un cantastorie, nativo di Noha, che ascoltavo da tempo e che quest'estate ho avuto la fortuna di conoscere personalmente mentr'era attento a vendere musicassette dietro una bancarella al mercato di Galatina. Poi ho voluto conoscerlo meglio, sono stato a casa sua e non potevo aspettarmi altro che quel personaggio che traspare dalle sue canzoni, e cioè un contadino che ha saputo tirar fuori tanta arte dalla sua faticosa esperienza di vita.
E' una voce popolare autentica che non ha niente a che fare con altre voci del Salento che pur hanno un giro commerciale.
Il titolo del lavoro è tratto da una sua canzone «Lu furese ‘nnamuratu», un omaggio a questo menestrello che ha trascorso la vita cantando l'amore.
Mi preme soprattutto porre Luigi Paoli all'attenzione di un certo tipo di intellettuali, di borghesi, di giovani anche, in ogni caso gente estranea al mondo contadino, che snobbano un certo tipo di canzone popolare, considerandola minore se non addirittura volgare. Io so che la gente va ancora matta per certi ritmi o testi che, pur nella loro semplicità, si fanno interpreti di un gusto, un mondo che va scomparendo.
A mio giudizio c'è dell'arte in Paoli se l'arte, oltre ad essere prima di tutto un fatto estetico è però anche rappresentativo. Mi pregio di aver scoperto Paoli o meglio Gigetto, come si fa chiamare. Ne ho approfittato, tra l'altro, per dire la mia su alcuni aspetti poco noti ma interessanti della canzone popolare salentina.
Alfredo Romano
[1] Carlo Caggia, direttore del Corriere Nuovo di Galatina.
*********************
GIGETTO DI NOHA OVVERO LUIGI PAOLI
L’ULTIMO “FURESE ‘NNAMURATU” DEL SALENTO
"Durante la guerra mio padre suonava il flauto per gli Americani a Brindisi, ed io l'accompagnavo con la mia bianca voce di bambino, per campare. Tempi tristi!".
Comincia così il racconto di Luigi Paoli, un cantastorie, un menestrello, un musicista popolare nato a Noha 48 anni fa e residente a Spongano in una bianca e comoda casa di periferia, con immancabile terrazza e orto giardino, e la cantina, dove le botti suonano di pieno e versano a me, fortunato visitatore, un negramaro robusto, profumato.
Non è facile orientarsi nel mercato minore della canzonetta popolare ora che molti improvvisatori sprovveduti si sono lanciati in questo folk alla moda che non ha niente di peculiare e scimmiotta anzi un certo liscio romagnolo omogeneizzato che imperversa nelle sale e sulle piazze di tutt'Italia.
Basta un po' di gusto però per capire che Luigi Paoli, da trent'anni, nel solco di una tradizione propriamente salentina, elabora testi po¬polari, li arrangia, ne inventa di nuovi per un pubblico non solo salentino, meridionale in genere, emigranti soprattutto (in Australia perfino, in Canada) che curano l'amara nostalgia al ritmo di suoni e canti che ricreano l'atmosfera della terra natia. II suo racconto si dipana lentamente in un gesticolare ampio. La voce, il corpo, assumono una dimensione teatrale, un viso pienotto, da scatinatore, occhi neri e luminosi, a sottolineare un sorriso perenne, contagioso.
Il più piccolo di cinque fratelli maschi, orfano di madre a quattro anni, a otto guardava le capre presso un guardiano di Noha. Un giorno, per via che, assetato, aveva impunemente bevuto in un secchio d'acqua tirata dal pozzo destinata alle capre (pare che le capre si rifiutino di bere dove ha già bevuto un altro, n.d.r.), venne appeso al ramo d'un albero a testa in giù, e, come una bestia, bastonato di santa ragione. Quest'episodio acuirà la sua sensibilità di fanciullo, rivelatore di una futura carica umana che Paoli, da grande, saprà trasfondere nella sua musica.
Di quei tempi funzionava a Noha una, chiamiamola così, palestra di vino e canti che era la puteca te lu nunnu Totu te lu Vergari che Gigetto frequentava in compagnia del padre. Qui rallegravano le serate certo Girbertu e certo Marinu Ricchitisu di Aradeo con quel popolarissimo strumento che è la fisarmonica. È qui che Gigetto affina la voce e il suo orecchio musicale; ma la fisarmonica è ancora un mito per lui e ci vorranno degli anni per farsi regalare solo una “Scandalli 24 bassi”.
Arriva poi la prima grande migrazione di salentini, dopo la guerra, nelle campagne di Bernalda, Pisticci, Scansano Ionico, Ginosa Marina, ecc., per dare inizio a estese coltivazioni di tabacco. Questo tabacco, per necessità o malasorte, i salentini ce l'hanno nel sangue e, più della vendemmia o della raccolta delle ulive, rappresenta una forma di maledizione divina che ti perseguita fin da ragazzo. Nasce così, da questa fatica centenaria, tutta una cultura del tabacco fatta di canti, stornelli, motti, proverbi che in molti casi rispecchiano le amare condizioni di vita esistenti allora nelle campagne. In quei grandi capannoni, soffocati dall'afa estiva, mentre s'infilzava tabacco: "Gigettu, 'ttacca, ca nui ne menamu te contracantu", continua Paoli nel suo narrare.
Amore miu sta sona matutinu
àzzate beddha àzzate beddha
ca lu tabaccu imu scire cujimu
cinquanta are te tabaccu tenimu chiantatu
se bruscia tuttu e lu perdimu.
Ulìa cu te ncarizzu beddha mia
e nu te pozzu mancu tuccare
chine te crassu tegnu le ma ne.
Non c'erano donne in casa e Gigetto s'adattava a lavare, cucinare, fare il pane, la pasta per il padre e i fratelli più grandi. A sera poi, finito il lavoro, inforcava una bicicletta senza freni e senza luce fino a Bernalda, 9 Km., a lezione di musica dal maestro Troiani. Cento lire gli costava, quanto un giorno di lavoro.
I progressi di Gigetto convincono i due fratelli maggiori, emigrati in Inghilterra nel frattempo, a spedirgli il denaro per l'acquisto di una fisarmonica vera, una Paolo Soprani 120 bassi. "E cci me parava, caru miu, cu ‘nna 120 bassi… te nanzi 'Ile signurine, quandu trasìa intra le case: ssèttate ssèttate, li primi valzer, la raspa, un po’ a orecchio, un po' a musi ca...". Nasce anche la prima composizione, naturalmente per la sua Noha, sulla misteriosa Villa Carlucci che, da bambini, si raccontava essere il regno del diavolo, di strani folletti.
Un giorno, sedicenne ormai, mentre era attento in uno stretto sgabuzzino a provare un esercizio sulla fisarmonica, ecco dalla sponda di un'Apetta, scendere Cecilia con madre e sorelle venute anche loro a far tabacco dalla lontana Spongano. "In quelle masserie sperdute dove non appariva donna viva, malati di solitudine, dove contavi le ore del sole nel suo levarsi e sparire, Cecilia, col suo bel visino e il petto già pronunciato, fu un colpo di fulmine".
L'inverno, poi, Cecilia ritornava a Spongano e Gigetto, con la solita bicicletta, percorreva 180 Km, allora di strada bianca, per stare qualche ora con la sua bella. Questa bella sarà l'ispiratrice di tante sue canzoni, questa bella, di cui oggi è ancora perdutamente inna¬morato, che gli ha dato sei figli, che lo segue per i mercati del Salento e che sa dividere con lui l'arte d'arrangiarsi dietro una bancarella.
Poi la fuga, allora d'uso, per sposare Cecilia e, qualche mese dopo, in Costarica a piantare banane e canna da zucchero. Paoli ha steso un velo qui nel suo racconto, dice che sarebbe troppo lungo. A me, che vorrei saperne di più, piace l'idea di vedervi celato un qualche mistero.
Si ritorna in Italia, ma non si campa e, questa volta da solo, con la usuale valigia di cartone, in Germania a fare il manovale chimico. "Non stavo male in fabbrica, ma ogni sera era un tormento e le foto di Cecilia e dei miei bambini in capo al letto mi ammalavano di nostalgia. Così non potei resistere a lungo".
Definitivamente a casa, ma con qualche idea. In fondo ha una bella voce e suona bene la fisarmonica. Si presenta per un provino a Locri in Calabria. È il 1962, Paoli incide i primi dischi: Tuppi tuppi la porticella, La tarantola salata e numerosi balli strumentali che lui sa arrangiare con un'arte che gli deriva, più che dallo studio, da una cultura musicale essenzialmente popolare. Andatevi ad ascoltare queste prime incisioni: hanno un fascino di registrazione sul campo, c'è addirittura un saltarello con ciaramella, uno strumento montanaro col quale Paoli aveva familiarizzato nel soggiorno in Lucania.
In quegli anni poi andavano in voga storie popolari strappalacrime, tratte da tragedie vere o presunte e significative sono nella sua produzione due storie, l'una, II cieco del Belgio, narra di un emigrante che perde la vista nel crollo di una miniera e al suo ritorno a casa, la moglie, interessata solo alla sua pensione, non gli risparmia le corna; la seconda, s’intitola La matrigna cattiva, in quattro parti, dove si narra dì una bambina orfana buttata in pasto a una matrigna che tenta di avvelenarla e sarà punita per questo con cinque anni di carcere. Ambedue le storie Paoli le fa cantare all'allora piccola primogenita Cerimanna. Sono storie che oggi fanno un po' ridere, ma guardatele con gli occhi del tempo e non meravigliatevi se le mamme di mezza Italia hanno pianto ad ascoltare quelle storie. Fu tale il successo, che i falsari di Napoli lanciarono sul mercato migliaia di copie e per Paoli andarono in fumo alcune speranze di guadagno.
Sessantotto, rivoluzione nei valori, nei costumi, si scopre il popolare, si scoprono la lingua, gli usi, i costumi di una civiltà contadina che sta scomparendo. Le case discografiche si danno da fare a scovare questi anonimi canzonettisti popolari degni di un pubblico più vasto. A Paoli s'interessa la Fonola di Milano. Inizia così una vasta produzione musicale che ancora oggi continua. Dodici musicassette in attivo, qualche altra in cantiere, che hanno sorvolato gli oceani, è il caso di dirlo, senza quella pubblicità di cui si servono "i grandi", ma in virtù della parola che si trasmette, un tam-tam, quasi una tradizione orale che ancora resiste.
Diamo uno sguardo a questa produzione. Innanzitutto canzoni e balli strumentali attinti alla tradizione che Paoli arrangia in modo originale con delle varianti sia nel testo che nella musica degne di essere popolarmente connotate. Cosa significhi "popolare" nella canzone è presto detto. Semplicemente Paoli dice: "E’ quandu ‘na canzone la ponnu cantare cinquanta cristiani tutti assieme, trenta femmame ca sta tàjanu l'ua: una cu ttacca e ll'addhe cu tràsanu a cuncertu".
Abbiamo così la pizzica in più versioni col predominante ritmo del tamburello, e Santu Lazzaru, questo canto cristiano che i Grecanici ci portavano 'rretu le porte te casa nel cuore della notte durante la Settimana Santa.
Canzoni d'amore tante, un amore represso che acquista nel canto un moto liberatorio. Lu furese 'nnamuratu, forse la canzone più bella, dove accanto a una visione del lavoro come dura fatica, Paoli prorompe in:
Comu l’àggiu stringere e baciare
Te lu musicchiu sou sangu ha bessire.
(Come la devo stringere e baciare / dal suo muso sangue deve uscire).
La Carmina, dove il bi sogno d'amare è accorato, disperato quasi:
Mamma iu moru
e la Carmina nu’ lla provu
Beddha mia fatte sciardinu
fatte menta e petrusinu...
(Mamma io muoio / e Carmina non l’assaggio / Bella mia fatti giardino / fatti menta e prezzemolo).
E canti e strofe carnascialesche, condite di allusioni piccanti, volgari quasi, ma di una volgarità allegra, simpatica:
Nc'è lu zitu cu la zita
allu pizzu ti la banca
la manu camina te sotta
lu canale dell'acquedotta.
(C’è il fidanzato con la fidanzata / allo spigolo del tavolo / la mano scivola sotto / il tubo dell’acquedotto).
Allusioni che non risparmiano un certo tipo di prete alla Papa Cajazzu al quale non piace chiaramente confessare le vecchiette, bensì le zitelle. In verità molte canzoni, come proverbi e culacchi, rivelano un certo anticlericalismo, anche se molo bonario, diffuso nella nostra gente. E poi canti e stornelli che hanno il ritmo di un lavoro e ti pare di vendemmiare o d’infilzare tabacco in qualche capannone. Non mancano le canzoni tristi per gli emigranti, per quelli che stanno a soldato, per il carcerato che fatalmente al ritmo di una tarantella grida:
Menatine ‘sti corpi chianu chianu
ca suntu testinati pe' mmurire…
(Buttate i nostri corpi piano piano / ché sono destinati a morire).
Naturalmente non tutto è eccelso. Accanto a testi di un certo valore artistico, si alternano altri in cui Paoli piega a seduzioni commerciali. E' laddove, per conquistarsi evidentemente un pubblico più largo, tenta delle melodie in un italiano a lui non confacente. Diciamo subito che a Paoli è più congeniale il testo salentino dove è capace di sfumature e modulazioni possibili solo a una voce popolare tradizio¬nalmente educata come la sua. Ascoltatelo nella canzone Lu trainieri, per es., dove la voce, bellissima, affronta tra l'altro toni decisamente alti. Il tono alto è in verità una caratteristica del canto salentino, cosi come il controcanto, che Paoli sfrutta in tutte le sue canzoni ponendolo una terza sopra, mai sotto la melodia stabilita. Come nella tradizione. L'effetto è tale che è come ascoltare l'eco di una persona che canta a distanza portandosi ad arco la mano sulla bocca. Alle origini di questa forma c'è, evidentemente, la necessità del "lavorar cantando" tra contadini distanti fra loro.
Un discorso a parte merita la fisarmonica, la protagonista di tutti gli arrangiamenti di Paoli. Nelle sue mani diventa magica e ci sono tanti e tali di quegli abbellimenti, non trascrivibili in partitura, che userei chiamarla barocca, in sintonia con una Terra che barocca lo è perfino in cucina e non solo nell’architettura delle chiese e delle case.
C'è una cosa che colpisce nella musica di Paoli, ed è un certo influsso orientale avvertibile in canzoni come la sopracitata Lu trainieri e La vecchiaia è 'na carogna. Qui sia la voce che la fisarmonica assumono un andamento cromatico, orientaleggiante appunto, e la melodia, di particolare bellezza, scivola sul filo dei sogni arcani, un lamento, un pianto quasi dal profondo d'inesplorati abissi.
Ma ciò che più fa scattare l'interesse per le musiche di Paoli è qualcosa di più misterioso che non saprei definire. Propriamente ci si sente scazzicati, come morsi da una tarantola, e vien voglia di abbandonarsi a una danza frenetica, liberatoria.
Quale ragno nascosto nei meandri di grigie pietre assolate, Paoli ci attende al varco esercitando su di noi una qualche magia. Non sarà vero, rna ci piace pensarlo.
Alfredo Romano
Da Il Corriere Nuovo di Galatina, n. 7 del 30 settembre 1983
fonte www.pizzicata.it
ago312020
Il primo settembre del 1920, otto pionieri fondatori - cui si aggiunsero immediatamente i primi trenta soci ordinari - diedero i natali al Circolo Cittadino di Noha. Dopo aver approvato lo statuto all’unanimità, ne inaugurarono la sede in due ampi locali con volta a botte al piano terra del “fortissimo Castello di Noha, posto in forte loco”. Tutti si strinsero le destre e bevvero un bicchiere di vino locale alla salute del novello sodalizio, ripetendo nei loro prosit la frase attribuita a Giulio Cesare dal suo biografo Svetonio: “Alea iacta est” (il dato è stato lanciato): questo motto, insieme allo stemma civico delle tre torri, e ad altre immagini allegoriche, fu effigiato in un bel quadro da Michele D’Acquarica (1886 – 1971), che da quel dì ha campeggiato solenne nella diciamo aula magna dell’associazione, oltre che sul suo vessillo.
 |
 |
Fu denominato Juventus, questo cenacolo, vale a dire la Gioventù, senza alcun riferimento né alla squadra di calcio (la quale, benché fondata nel 1897, era allora sconosciuta perfino agli Agnelli), né alla prosopopea fascista (ché i suoi apologeti, più o meno consapevoli, sembrano più numerosi oggi di quelli di cent’anni fa): ma sin da subito fu da tutti conosciuto come il Circolo. Quando si dice l’antonomasia.
All’epoca regnava ancora casa Savoia nella persona di re Vittorio Emanuele III (e non si capisce perché l’odonomastica da nord a sud sia ancora così indulgente con il sovrano “sciaboletta”); il presidente del consiglio era Giovanni Giolitti, mentre al di là del Tevere indossava la tiara di pontefice massimo Giacomo Paolo Giovanni Battista della Chiesa che la cristianità cattolica onorò con il nome di Benedetto XV. Sulla cattedra di Nardò, cui la chiesa particolare di Noha apparteneva fino al 1988, sedeva il biscegliese Nicola Giannattasio, intanto che sindaco di Galatina era il dottor Vito Vallone, medico del popolo, dimissionario nel 1923, quando ormai il fascismo aveva preso piede, e ben altre famiglie alto-borghesi, come i Bardoscia, i Venturi, e il ramo di Domenico Galluccio avevano in pugno città e frazioni.
 |
 |
L’arciprete di Noha – che allora annoverava poco meno di 2000 anime - rispondeva al nome di don Vito Antonio Greco (parroco, costui, del rifacimento della facciata della matrice di San Michele Arcangelo, inaugurata nel 1901), coadiuvato da don Pippi Piscopo, don Ippazio Apollonio e don Isaia Blago e, a partire proprio dal 1920, anche da don Paolo Tundo, suo sostituto ed economo curato, poi monsignore, che gli succederà nell’archipresbyteratus nohano nel 1934.
Il Novecento fu un secolo così breve che non basterebbe un’enciclopedia intera per abborracciarne una sua pur stringata epitome. Ma non si può omettere il fatto che il 1920 fu l’ultimo anno della Spagnola (iniziata due anni prima), definita dagli storici come la più grave forma di pandemia dell’umanità, più mortale della peste nera del XIV secolo. Nonostante tutto, codesti soci coraggiosi, stanchi di “peste fame et bello”, decisero di dar vita a un diciamo assembramento, e questo fu così solido e longevo che proprio oggi taglia il nastro del secolo di vita.
Del ventennio fascista e del tramonto della libertà cittadina non è il caso di parlarne oltremodo (tanto chi sa sa, mentre chi non sa crede agli asini volatili e vota di conseguenza), ma sul tema non posso non uscirmene - sperando non mi si tacci di ermetismo - con uno degli epigrammi del Manzoni, ma al rovescio, e cioè dal manzoniano: le cappe che s’inchinavano ai farsetti al melloniano: all’orbace s’inchinava la lana di capra (capre che, sopra o sotto i palchi dei comizi, erano e sono tuttavia ancora maggioranza).
La Storia (come la natura) non fa salti, ma grandi falcate sì, sicché tra sopruso e manganello, il duce e i suoi ducetti portarono l’Italia in guerra: la seconda mondiale. Noha, che dopo la prima non s’era mai ringalluzzita (nonostante appunto i Galluccio, o forse anche a causa loro), ripiomba nello sconforto e nella miseria determinati anche dalla partenza verso il fronte prima e verso la prigionia poi delle sue braccia più forti e delle sue menti più vivaci, forse le migliori, certamente le più giovani. Il Circolo ne risente eccome, e in questo periodo, come molte altre istituzioni, più che vivere sopravvive.
Gli anni ruggenti a Noha iniziano finalmente nel secondo dopoguerra. Si riprende l’agricoltura (che era, e non potrà che esser sempre il settore primario, quello senza il quale nessuno di noi esisterebbe), la pastorizia, l’allevamento, l’artigianato, la piccola industria (vinicola, conserviera, la fabbrica del Brandy), e ovviamente il micro-commercio, e quindi di pari passo anche il numero degli iscritti al Circolo Cittadino.
Le regole del circolo prevedono la laicità, ma nel senso più ampio del termine, soprattutto nel senso dell’apartiticità, per cui s’è spesso ripetuto: “Qui non si parla di politica” (che poi è il modo migliore per parlarne quasi sempre), onde le discussioni avvenivano in gruppo, spesso seduti a ronda, magari afferrando una sedia per la spalliera e girandola in modo da sedersi con il petto contro la stessa spalliera (come fa nella foto il piccolo Simone).
Nei primissimi anni del secondo dopoguerra si sottoscrive l’abbonamento alla Gazzetta del Mezzogiorno, e non era infrequente la sua lettura ad alta voce, con conseguente commento di alcuni brani. Quasi di pari passo si acquista una bella radio nuova di zecca: una scatola di legno enorme con i riquadri luminosi e i nomi delle stazioni (Milano, Stoccarda, Vaticano, Istanbul…), gialli per le onde medie, rossi per le onde corte e verdi per le lunghe. La radio trasmetteva musica operistica, ovviamente la melodica, le commedie e il giornale radio e, fin dai primissimi anni ’60, “Tutto il calcio minuto per minuto” che teneva incollati letteralmente all’apparecchio tifosi e giocatori di schedine.
La TV a 27 pollici non tarderà ad arrivare, e con lei per fortuna anche un abbonamento pluriennale a L’Espresso (quante Bustine di Minerva di Umberto Eco ho letto da piccolo, allorché mio papà Giovanni mi dava “lu ‘ntartieni” in quel circolo di cui era socio – oggi, pare, il più anziano).
A proposito di televisione non si può non menzionare “Alla conquista del west”, la serie televisiva americana andata in onda nel 1979 che riempiva il salone di soci e loro accompagnatori fino all’inverosimile con l’epopea della famiglia Macahan [leggi Mechèin, ndr.], il cui capostipite Zeb “Mechèin” veniva da tutti appellato (ormai famigliarmente) Zi’ Micheli.
Insomma, mentre oggi gli uomini sembra non smettano di inventarsi nuovi metodi per vedersi quanto meno è possibile (dai social network al lavoro da casa), i soci del Circolo Cittadino sentivano invece il bisogno quotidiano di incontrarsi, guardarsi negli occhi, raccontarsi le storie, parlare di campagna, di vino e di tabacco, e magari di scambiarsi i semi delle piante migliori, e perché no d’estate degustare insieme qualche bella fetta di Mellone.
 |
 |
Da un paio d’anni, il circolo cittadino ha lasciato la sua sede storica per trasferirsi in un’altra più piccola proprio in piazza San Michele, a poche decine di metri dalla precedente. Il suo nuovo presidente, nella persona di Antonio Idolo (Papa ‘Ntoni), sogna il ritorno in massa dei soci, pronti, come allora, a discutere di fatti, a giocare a carte e a scacchi, a solidarizzare e ad abbracciarsi anche nei momenti tristi (come la dipartita di un socio o di un suo famigliare, allorché, prima di questo virus, la bandiera del circolo era la prima a sfilare in corteo): in breve, spera, e noi con lui, nella fine di questa, purtroppo ancora in corso, terza guerra mondiale.
* * *
Ai soci era sufficiente esserci, e non era necessario fare chissà quali discorsi, ché le parole a Noha, specie in passato, non si sono mai sprecate. Si racconta che una volta, al rinnovo di un consiglio direttivo, il presidente Gerardino Specchia invitasse il neo-eletto vice presidente Ninetto (la buonanima di Santo D’Acquarica, titolare del bar di piazza San Michele) al tavolo della presidenza per un “breve intervento di ringraziamento”. Orbene, Ninetto, si alza in piedi, prende il microfono, ci soffia dentro, dà due colpetti sulla capsula per provarne il funzionamento, un rapido sguardo alla platea, raccoglie i pensieri, prende fiato, e con la sua voce tonitruante, fa: “Crazzie!”.
Fine della dissertazione. Applausi.
Antonio Mellone
lug302021
Non so se qualcuno ricorda le autocarrozzerie di una volta, quelle che ti rimettevano a nuovo la macchina dopo le nozze d’argento (voglio dire le nozze tra te e la tua auto). Intendiamoci, non è che i carrozzieri odierni non facciano altrettanto, ché quanto a tecnologia sono così avanti che tramite computer, robot, software e meccatronica riuscirebbero anche a ricostruire i connotati del conducente come manco un chirurgo plastico: è che invece siamo cambiati noi altri, o meglio il rapporto con il nostro mezzo di locomozione: un tempo emblema di fedeltà assoluta (finché morte non ci separasse), oggi di volubilità, e addirittura in nome della transizione ecologica.
 L’Autobianchi 500 Giardiniera (cioè station wagon) caffelatte di mio papà Giovanni, per esempio, fu rifatta ab imis fundamentis dopo circa un trentennio dal taglio del suo cordone ombelicale con la concessionaria. Il carrozziere che si chiamava Antonio Rizzo e aveva la sua officina in via Aradeo fu così bravo da non farci quasi più riconoscere la nostra vecchia Famigliare decappottabile: nuova di fabbrica sembrava, fiammante, profumata, “smaltata” nel suo originario colore neutro tattico (così – a parere della regina madre - non si sarebbe notato lo sporco). Il portapacchi in cima, ridipinto d’argento, era la corona di una principessa. Quella povera auto da soma che aveva caricato mante di tabacco, frese, zappe, tini d’uva, rape e cicorie, sacchi di grano, e due volte l’anno tutte le masserizie necessarie per “ritirarsi” in campagna ovvero per rientrare al paese a fine estate, sembrava pronta per un matrimonio di lusso. Le mancava giusto il fiocco di tulle.
L’Autobianchi 500 Giardiniera (cioè station wagon) caffelatte di mio papà Giovanni, per esempio, fu rifatta ab imis fundamentis dopo circa un trentennio dal taglio del suo cordone ombelicale con la concessionaria. Il carrozziere che si chiamava Antonio Rizzo e aveva la sua officina in via Aradeo fu così bravo da non farci quasi più riconoscere la nostra vecchia Famigliare decappottabile: nuova di fabbrica sembrava, fiammante, profumata, “smaltata” nel suo originario colore neutro tattico (così – a parere della regina madre - non si sarebbe notato lo sporco). Il portapacchi in cima, ridipinto d’argento, era la corona di una principessa. Quella povera auto da soma che aveva caricato mante di tabacco, frese, zappe, tini d’uva, rape e cicorie, sacchi di grano, e due volte l’anno tutte le masserizie necessarie per “ritirarsi” in campagna ovvero per rientrare al paese a fine estate, sembrava pronta per un matrimonio di lusso. Le mancava giusto il fiocco di tulle.
Poi mio padre, monogamo per indole e convinzione, l’ha utilizzata fino alle nozze d’oro, che dico, di diamante e mi pare pure di platino (sempre tra lui e la 500 dico): mai un incidente, ricovero in garage la notte, e lavaggio con spugna secchio e suca (pompa collegata al pozzo), ma soltanto quando non se ne poteva più fare a meno.
Tutto questo per introdurre la storia dell’autocarrozzeria di Pietro Serafini, e per dire che c’è ancora chi è legato ai cimeli locomotivi del passato e che per poterne nuovamente godere deve trovare chi se ne occupi con passione e competenza. Sia chiaro, a Noha è pieno di artigiani del settore: abbiamo officine rinomate in tutto il Salento, o meglio in tutta d’Italia (basta leggerne le recensioni on-line); addirittura Antonio della F.lli Mariano, oltre a essere il presidente regionale della Confartigianato del settore, siede anche nel direttivo del Consiglio Nazionale, per non parlare di quei colossi che rispondono ai nomi dei F.lli Bonuso e di Idolo Officine che portano in giro per il mondo (appiccicato alle targhe degli autoarticolati transitati dal loro pronto soccorso) il nome di Noha, e per finire a Ciofficar dei Cioffi, padre e figlio, anch’essi professionisti ad alti livelli.
 Dunque non farò un torto agli altri carrozzieri di Noha se questa volta tratto del più piccolo fra loro, Pietro appunto, che nel 2015 ereditò la carrozzeria del papà Roberto, il quale aveva deciso, prematuramente, di andare a riparare le ali degli angeli.
Dunque non farò un torto agli altri carrozzieri di Noha se questa volta tratto del più piccolo fra loro, Pietro appunto, che nel 2015 ereditò la carrozzeria del papà Roberto, il quale aveva deciso, prematuramente, di andare a riparare le ali degli angeli.
La carrozzeria di Pietro la trovi in via Cadorna al 49, a un fischio dai giardini Madonna delle Grazie e, pur micro, è dotata di tutto quel che occorre: banconi, strumentazioni le più disparate, l’impianto per la verniciatura, il forno per l’essiccazione della dipintura. Ma prima di tutto trovi la pazienza, l’olio di gomito del titolare, la sua arte.
Pietro, trentasei anni d’età e quaranta di esperienza, mascherina, scarpe antinfortunistiche, guanti e tuta di prima mattina, studia i pezzi, si fa uno schema delle procedure e s’immerge nel suo lavoro senza sosta. L’ultima volta che lo vidi era alle prese con una “cosa degli anni ’60”, mi disse: il proprietario non aveva voluto interventi di altri se non il suo, e gli aveva presentato un ferrovecchio osando definirlo “la mia Vespa”. Ebbene quel “ferrovecchio” tempo dopo, non so più in quale concorso, s’era aggiudicato quale primo premio una targa d’oro: una medaglia al merito che starebbe bene anche sul petto di questo cerusico estetico di automezzi.
Non finirei più se volessi scendere nei dettagli del lavoro di questo ragazzo, la sua inventiva applicata agli attrezzati specifici che di volta in volta addirittura s’inventa per salvare geometrie distrutte, la ricostruzione dei punti di riferimento del progetto iniziale, la gestione dei piccoli spazi di un’officina dove non vola nemmeno un granello di polvere, la più duratura stagnatura (che comporta tempo e lavoro) che Pietro s’è incaponito di utilizzare al posto della più caduca stuccatura dei pezzi (più facile e veloce), e la sua tenacia nel non tirarsi mai indietro qualunque catorcio ignobile gli venga presentato per la rianimazione.
 Capitoli di molte pagine a parte meriterebbero la sua disponibilità a lavorare con spirito di abnegazione per la comunità (l’ha già fatto ad esempio riportando al suo antico splendore il marchingegno dello storico orologio della torre civica di Noha, oggi esposto nei locali della Scuola Media), nonché il commovente filiale bisogno di conversare ancora, nel suo ideale dialogo quotidiano, con il suo (e nostro) mesciu Roberto.
Capitoli di molte pagine a parte meriterebbero la sua disponibilità a lavorare con spirito di abnegazione per la comunità (l’ha già fatto ad esempio riportando al suo antico splendore il marchingegno dello storico orologio della torre civica di Noha, oggi esposto nei locali della Scuola Media), nonché il commovente filiale bisogno di conversare ancora, nel suo ideale dialogo quotidiano, con il suo (e nostro) mesciu Roberto.
Antonio Mellone
dic122017
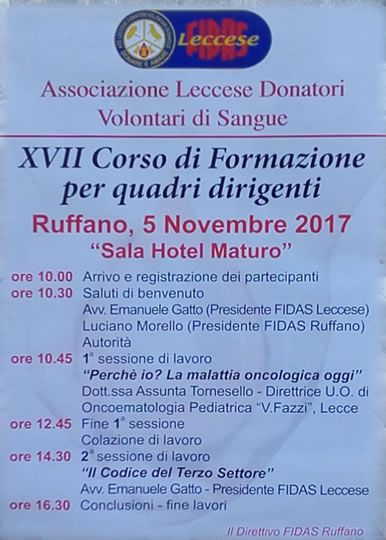 E’ domenica mattina. Anche se si è lavorato tutta la settimana e quindi si è stanchi, quando il cielo è azzurro e l’aria mite, è preferibile stare fuori all’aperto piuttosto che impigrirsi nel letto.
E’ domenica mattina. Anche se si è lavorato tutta la settimana e quindi si è stanchi, quando il cielo è azzurro e l’aria mite, è preferibile stare fuori all’aperto piuttosto che impigrirsi nel letto.
Quindi ci ritroviamo davanti alla sede Fidas-Noha di via Calvario, pronti e puntuali, come esige il buon rapporto con impegni collettivi, come questo organizzato da Fidas - Leccese per la formazione dei suoi quadri dirigenziali.
La prima parte della giornata formativa, tratta un argomento che accomuna l’interesse di molti di noi: la malattia oncologica oggi. Purtroppo stiamo vivendo già da alcuni decenni, un periodo storico che possiamo paragonarlo a quello della peste nera. Come me credo che un po’ tutti siamo sul chi va là per via della specificità della materia, quella della medicina e ci attendiamo una mattinata difficile per via della probabile astrusità dei termini tecnici. Ma al contrario delle aspettative, il dottore Alessandro Cocciolo, che fra l’altro sostituisce la dott.ssa Assunta Tornesello, Direttrice U.O. di Oncoematologia Pedriatica “V. Fazzi”, Lecce, è molto chiaro nell’esposizione, usa una terminologia alla portata delle mie (e credo di tutti) conoscenze e porta una ventata di relativa positività sulla situazione sanitaria del Salento.
Mi sorprende infatti sentirgli dire, in più occasioni, che il Salento, in quanto a percentuali di tumori, è in linea con l’Italia. Per la prima volta, una raccolta dati (quella di AIRTUM: Associazione Italiana Registro Tumori), è testimone di una notizia simile, in questi ultimi anni, molte testate giornalistiche hanno diffuso allarmi tutt’altro che positivi in area Lecce, Maglie e Galatina (Per esempio: “Noteremo che i distretti di Maglie e Galatina hanno numeri abnormi. E la spiegazione non può essere il fumo di tabacco. Di certo, c’entra la pressione ambientale.” http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/09/29/salento-e-emergenza-tumore-ai-polmoni-ma-a-nessuno-interessa-sapere-motivi/726641/).
Per la prima volta sento dire: “Incidenza tumori in calo”; “Mortalità in calo”.
Sento parlare di fare Prevenzione Primaria, e cioè eliminare e non produrre più inquinanti, di aumentare la Prevenzione Secondaria (indagini, screening, ecc) cosa ancora non ben radicata (forse) qui nel nostro Salento. Di evitare l’uso di prodotti alimentari conservati, e invece la grande distribuzione ce li impone.
Anche qui penso e mi riallaccio alla differenza fra i grandi centri commerciali alle grandi catene di supermercati (vedi l’ennesimo Pantacom) e ai nostri vecchi e numerosi negozietti di paese.
E poi, dulcis in fundo, la ciliegina sulla torta, il dr. Cocciolo apre il capitolo delle intolleranze alimentari ed esordisce: “Non ci sono incidenze tumorali, anzi se una persona sorveglia le proprie intolleranze abbatte l’incidenza tumorale e le relative problematiche”.
Mi viene da dire: grazie dr. Cocciolo, per queste “buone notizie”. Lo penso davvero, ma il mio pessimismo mi porta a indagare, ad andare avanti nell’arte dell’osservare con il dubbio. Ciò non toglie che comunque una ventata di aria fresca il dr. Cocciolo ce l’abbia fatta passare veramente.
Questo non ci deve consolare, in quanto i numeri di mortalità sono alti, basta guardare anche solo a Noha quante sono le persone morte prematuramente a causa dei tumori. I casi di mortalità in ambito nazionale, dice il dr. Cocciolo, sono molto più numerosi di una guerra (176000 morti all’anno). Quindi il fatto che il Salento sia allineato con il resto del Paese Italia va bene, ma NON deve farci abbassare la guardia, soprattutto a noi di Fidas, che avendo una certa sensibilità e responsabilità, siamo degli osservatori attivi nel volontariato.
E’ stato interessante sapere che le cellule tumorali si manifestano per il 20% da familiarità e per l’80% per predisposizioni genetiche combinate con fattori ambientali. Questo vuol dire che non possiamo più fare a meno di ascoltare e interpretare i segnali che il nostro corpo ci dà (prevenzione) e soprattutto non possiamo più trascurare l’ambiente, in quanto attore e protagonista della nostra salute. Il dr. Cocciolo non si è limitato a parlarci di cellule e di percorsi processuali delle loro variazioni, ma ha chiarito concetti che spettavano e spettano alle istituzioni come Arpa e Asl, ecc. che si devono occupare degli inquinanti pericolosi quali amianto, benzene, catrame, carbon fossile, ecc. (questo argomento mi ha subito richiamato alla mente i 14 km quadrati di carbone che Colacem di Galatina tiene stoccati a cielo aperto). Quindi ascoltando la lezione del dr. Cocciolo nascono interessanti intrecci con altre notizie e questo ci permette di essere più informati. Essere informati vuol dire anche essere dei buoni diffusori.
Il quadro di rappresentazione del contesto in cui viviamo e dei prodotti che adoperiamo è stato veramente ampio, non solo limitato al campo specifico della medicina, insomma un vero e proprio documentario alla Piero Angela. Se dovesse ripetersi lo ascolterei ancora molto volentieri e lo consiglio a tutti.
Non possiamo più delegare e ignorare, questo ha voluto in sintesi farci intendere il dr. Alessandro Cocciolo con la sua serena esposizione di fatti anche drammatici.
La seconda parte della giornata di formazione, ahimè costretta nella fase digestiva del dopo “colazione”, non risplende di cotanto trasporto, ma alla fine anche qui, la diabolica maestria espositiva e simpaticissima voce del nostro Presidente Emanuele Gatto (Gerry Scotti in confronto è un vero dilettante), ci permette di aggiungere al nostro bagaglio culturale anche le pesantissime note relative alla riforma del Terzo Settore e di come si abbatterà sulla nostra Associazione.
Così, fra numeri di articoli che si susseguono velocemente, registri telematici in arrivo, decreti legislativi, non più Onlus, non più Associazioni di Volontariato, ma semplicemente ETS (Ente del Terzo Settore), non più albi regionali ma un unico Nazionale, tra piattaforme virtuali e nuovi certificati relazionali, in attesa di un nuovo organo di controllo, finiremo tutti per confluire in una rete associativa, e speriamo che sia di maglia non tanto larga per tenerci tutti uniti. Perché solo uniti si può vince.
Marcello D’Acquarica
giu242018
 Questo quarto appuntamento di Tour d’Autore è dedicato al tabacco ed alla tabacchicoltura salentina. Punto di partenza sarà il libro di Salvatore Colazzo “I Tabacchi Orientali del Salento - Quattro storie e loro dintorni” Giorgiani Editore. Lavoro di studio e recupero , di un passato che pur recente e con tracce ancora visibili sul territorio, ha subito una “damnatio memoriae” collettiva. L’ autore, in questo suo primo volume, ricostruisce la storia del tabacco, dal ‘500 fino alla fine dell’800. Al novecento sarà dedicato un altro volume in fase di preparazione. Ripercorreremo la storia di questa pianta tanto odiata, quanto amata partendo dalla scoperta dell’America fino alle sperimentazioni avvenute nel Salento ed all’’introduzione delle varietà orientali che ne hanno caratterizzato tanto la produzione. Conosciamo alcune delle varietà levantine del tabacco anche da pagine straordinarie come quella dedicata allo Xanti Yaca di Vittorio Bodini :
Questo quarto appuntamento di Tour d’Autore è dedicato al tabacco ed alla tabacchicoltura salentina. Punto di partenza sarà il libro di Salvatore Colazzo “I Tabacchi Orientali del Salento - Quattro storie e loro dintorni” Giorgiani Editore. Lavoro di studio e recupero , di un passato che pur recente e con tracce ancora visibili sul territorio, ha subito una “damnatio memoriae” collettiva. L’ autore, in questo suo primo volume, ricostruisce la storia del tabacco, dal ‘500 fino alla fine dell’800. Al novecento sarà dedicato un altro volume in fase di preparazione. Ripercorreremo la storia di questa pianta tanto odiata, quanto amata partendo dalla scoperta dell’America fino alle sperimentazioni avvenute nel Salento ed all’’introduzione delle varietà orientali che ne hanno caratterizzato tanto la produzione. Conosciamo alcune delle varietà levantine del tabacco anche da pagine straordinarie come quella dedicata allo Xanti Yaca di Vittorio Bodini :
l Al tempo dell'altra guerra contadini e contrabbandieri
si mettevano foglie di Xanti-Yaca
sotto le ascelle
per cadere ammalati.
Le febbri artificiali, la malaria presunta
Di cui tremavano e battevano i denti,
erano il loro giudizio
sui governi e la storia.
Appuntamento alle ore 19:00 presso Hostaria Amarcord in Piazza San Pietro con la presentazione del libro di Salvatore Colazzo “I Tabacchi Orientali del Salento- Quattro storie e loro dintorni” Giorgiani Editore. Con l’autore Salvatore Colazzo , dialogherà Antonio Mellone profondo conoscitore del Salento con le sue dinamiche, trasformazioni e tradizioni e Francesca Casaluci antropologa culturale. Introduce Andrea Panico di Note d’Arte.
Ci aiuteranno in questo viaggio anche foto, libri dell’epoca, documenti e video in una collettiva di autori, che sarà possibile visionare all’interno dell’Hostaria Amarcord e che rimarranno a disposizione dal 25 al 30 giugno. Si ringraziano per i contributi e per aver aperto i loro archivi : Ambrà Mongiò, Salvatore Colazzo, Franco Cudazzo, Pantaleo Musarò, Adalgisa Romano, Arts and Gallery, Alessandro Romano, Enzo Congedo, Rita Colazzo.
Ingresso gratuito
Salvatore Colazzo studia presso l’Università di Bologna , dove si laurea in Scienze Agrarie con tesi sui Tabacchi Orientali Italiani. Dopo un periodo di perizie in una struttura del comparto tabacchi colo seguono anni di insegnamento in Emilia Romagna. Vicende familiari lo portano a rientrare nella sua terra dove attualmente opera nel settore delle piante officinali. “I Tabacchi Orientali del Salento- Quattro storie e loro dintorni” Giorgiani Editore vuole essere un tributo a una pianta, la sua terra e la sua gente.
Emilia Frassanito
ott022023
 In occasione del consiglio comunale di oggi in cui è presente all'ordine del giorno un'interrogazione sull'opera muraria realizzata a Noha, ci preme sottolineare alcuni aspetti fondamentali del progetto firmato dall'amministrazione Amante.
In occasione del consiglio comunale di oggi in cui è presente all'ordine del giorno un'interrogazione sull'opera muraria realizzata a Noha, ci preme sottolineare alcuni aspetti fondamentali del progetto firmato dall'amministrazione Amante.
nov302006
Luisa Palumbo (La Isa): passione e lotta
Questa sera ho l’onore di parlare di un nome, celebrandolo (alla fine di ognuno di noi non resterà che il nome): quello caro di Luisa Palumbo (1920 - 2003), meglio nota come la Isa, e ancor più nota quale pasionaria di Noha.
Come vedremo la Isa, comunista convinta, è stata una sindacalista battagliera, protagonista delle lotte per la rivendicazione dei diritti degli ultimi. Ma prima di tutto questo, la Isa era una Donna!
Ne parlerò sul filo della memoria, delle testimonianze e soprattutto del cuore.
Scopriremo come sia vero il fatto che certe figure inquadrate in ambienti “provinciali”, come Noha, meritano di essere fermate finalmente sotto il flash della Storia, la quale, benché “locale” o “micro” (come dice Antonio Antonaci), dovrebbe essere comunque scritta con la maiuscola. Per capirci meglio, diciamo che la Storia locale è Storia tout court: non c’è più Storia di prima scelta e Storia di seconda scelta. Di fatto la storia generale non può fare a meno della micro-storia, quella delle piccole località e della gente non blasonata spesso testimone o protagonista “muta” della Storia: così come è vero che ogni mosaico è, del resto, fatto da mille piccole tessere, tutte importanti.
Questa sera, dunque, parlerò di una di queste tessere musive.
************************************************************************
Conobbi la Isa in circostanze particolari.
Eravamo nel 1983. La mia famiglia come numerose altre famiglie di Noha (e di Galatina) trovava sostentamento nell’agricoltura.
Nell’ambito di questo settore la coltivazione che assorbiva i pensieri e le energie e le ore del giorno e della notte di tutti i membri della mia famiglia, incluso il sottoscritto, era il tabacco…
Ora vi devo confessare che non solo non ho mai amato, ma neanche provato la pur minima simpatia questa coltura (e, a dirla tutta, nemmeno per le altre: verdura, vigneto ed uliveto, le principali, non collimavamo punto né con le mie aspirazioni, né con i miei hobby: l’idea dell’agricoltura quale sbocco occupazionale non mi sfiorava il pensiero: nemmeno come ripiego). Diciamo che la campagna mi sarebbe piaciuto intenderla al più come villeggiatura. Le mie braccia preferivano il carico di dieci libri pesanti, ma non uno di una “filza” di tabacco.
I miei genitori ovviamente non mi avrebbero permesso di trascorrere l’estate nel “dolce far nulla”: era un lusso che solo alcuni dei miei amici, più fortunati di me, potevano permettersi. L’ozio non era contemplato né negli schemi mentali né nel vocabolario dei miei familiari, e, a dire il vero, neanche nei miei.
Bisognava dunque trovare un’alternativa all’aborrito tabacco.
************************************************************************
Il bisogno aguzza l’ingegno anche dei ragazzini. Il mio mi portò in quell’amena località di mare al nord di Gallipoli che risponde al nome di “Lido Conchiglie”, dove venni assunto per tutta l’estate (e così per le successive quattro bellissime “stagioni”), in qualità di cameriere, alle dipendenze del grazioso hotel-pensione denominato appunto “Le Conchiglie”, un complesso turistico allora di proprietà proprio della signora Luisa Palumbo, nonna di Tony Serafini, un mio compagno di classe delle medie, qui presente, che di fatto era stato il mio “gancio”. Anche egli, colà, non era, oltre tutto, in vacanza, ma cameriere, al pari di me (non c’erano forme di nepotismo per la Isa!)…
************************************************************************
La proprietaria era, dunque, una anziana signora corpulenta, anziché no; ma attivissima, soprattutto in cucina, e combattiva, come vidi, financo al mercato del pesce di Gallipoli, dove conosciuta da tutti, veniva rispettata anche dal più incallito e smaliziato pescivendolo all’ingrosso.
La cosa che colpiva subito della Isa, a Lido Conchiglie dove visse gli ultimi vent’anni e più della sua vita, era un nugolo di cani e gatti che per la strada la seguivano o la precedevano: insomma l’accompagnavano ovunque movesse il suo passo lento e grave. Erano povere bestie randagie, abbandonate da gente violenta e senza scrupoli, delle quali la Isa si prendeva amorevole cura.
Questa donna dalla folta canizie, all’inizio mi sembrò burbera: compresi invece, in seguito alle nostre conversazioni (e ce ne furono molte) che la Isa aveva temprato il suo carattere coraggioso e agguerrito, ma in fondo altruista, alla scuola dura delle battaglie e delle mobilitazioni, degli scioperi e delle persecuzioni degli anni cinquanta che avevano finalmente interessato la provincia di Lecce; lotte senza le quali inesorabilmente si sarebbe rimasti ai tempi del feudalesimo dei servi della gleba.
************************************************************************
Mi rammarico di non aver approfondito e di non aver raccolto altre informazioni di prima mano da quella protagonista della Storia, animosa ed intrepida: quella donna che ha sfidato la storia del “ciclo dei vinti” (di verghiana memoria), contribuendo a cambiarla, questa storia!
Ma credo di esserne scusato: non ero che un imberbe sedicenne.
************************************************************************
La Isa fu un’attivista politica soprattutto negli anni cruciali delle lotte per i diritti delle tabacchine e successivamente negli anni delle contestazioni sessantottine, dove a Lecce, a Roma e altrove, era sempre in prima fila (lei allora casalinga) a fianco degli operai e degli studenti universitari, negli scioperi, nelle manifestazioni e nelle lotte che cambiarono il mondo, sulle note di “Avanti popolo”, “Bella ciao”, “L’Internazionale”…
Canti di Resistenza!
E sventolio di bandiere rosse con falce e martello, simboli del lavoro dei campi e delle fabbriche: vessilli che garrivano con fierezza ad ogni vento, specie se contrario.
Una volta le chiesi spiegazioni circa una sua cicatrice sulla fronte. Mi disse che si trattava del ricordo di un tumulto avvenuto nella capitale, allorché racimolò una manganellata sulla fronte, il cui segno (una ventina di punti di sutura!) rimase quale marchio indelebile della sua indole, che pare volesse dire agli interlocutori: “mi spezzo, ma non mi piego”.
La sua passione era quella di “contagiare” con le sue idee rivoluzionarie, lavoratrici e lavoratori, di quella voglia di libertà e di diritti necessari alla costruzione di una moderna democrazia. Soleva ripetere in codesta funzione, quasi didattica, nei confronti dei suoi concittadini: “…Accorgiamoci dell’ingiustizia! Se ci mettiamo insieme, se ci difendiamo, allora i padroni borghesi non possono far nulla. I diritti si ottengono con la lotta. Se non difendi il tuo pane, nessuno ti tutela…”.
Ed ancora: “Cercavamo di parlare alle tabacchine, in riunioni di caseggiato, nelle fabbriche, nelle borgate, nei locali più svariati per renderle edotte della loro condizione e dei loro tabù. Non era facile. C’era tanto da lavorare. Ce ne voleva per far comprendere questi principi.” (Queste appena proferite sono parole estrapolate dallo stupendo documentario di Luigi del Prete (anch’egli qui presente) intitolato “Le tabacchine. Salento 1944 – 1954”, edizioni Easy Manana; parole non molto dissimili da quelle che mi comunicava di persona).
************************************************************************
La Isa ha vissuto nell’ambiente rurale, come era quello di Noha, che non dava spazio a nessuno: figuriamoci ad una donna.
Mentre le altre compagne della stessa classe d’età della Isa negli anni ‘50 conducevano la loro vita di “schiavette” in seno alla famiglia o in mezzo ai campi (o le più “fortunate” in fabbrica) senza il diritto di parola o addirittura di pensiero, la Isa studiava, leggeva libri e riviste, e giornalmente “l’Unità”, quotidiano comunista (che cercava anche di distribuire e vendere specialmente nelle manifestazioni, anche come forma di autofinanziamento).
Le generazioni di oggi non possono avere nemmeno una pallida idea di cosa questo potesse allora significare: era questa una vera e propria rivoluzione, uno stravolgimento inaudito di uno status quo. Una donna poi!
Il lungo commercio con le lettere, la sua dote naturale di comunicativa, ma soprattutto le convinzione che era necessario agire, spingeranno la Isa a diventare un’agguerrita sindacalista, ovviamente della CGIL, o meglio una “capopopolo”, sempre presente nelle piazze e sui palchi dei comizi (anche improvvisati), nei quali sempre prendeva la parola: che scandiva con risolutezza e con un italiano impeccabile.
Si elevava in alto questa voce di Donna; e incantava, caricava gli animi scoraggiati dei “vinti”, quelli che ai propri figli potevano donare soltanto fame e freddo.
************************************************************************
La Isa diviene quasi un mito per i contadini di Noha e le altre operaie e tabacchine: la persona alla quale rivolgersi per ogni istanza, per la tutela e la rivendicazione dei diritti dei propri diritti di lavoratori: l’altra faccia dei diritti umani.
La Isa non spingeva alla ribellione soltanto per la povertà, la paga misera, il riconoscimento degli assegni di maternità, la fame, lo sfruttamento, la corruzione, ma soprattutto per il peso insopportabile della dignità calpestata e l’oltraggio del ricco: concessionario del tabacco o proprietario terriero che fosse.
La Isa non era affetta mai da timori reverenziali, nemmeno nei confronti del prefetto di Lecce, il tremendo Grimaldi, che voleva sminuire il valore della sua rappresentanza. La Isa fu una delle organizzatrici, insieme a tanti altri compagni, di uno sciopero straordinario (era il 24 settembre 1944). All’indomani di quella memorabile notte preparatoria la ribelle si presentò dal Prefetto, perché era di commissione, dicendogli: “Venga Eccellenza! Le faccio vedere le tabacchine che rappresento!”
Affacciatosi alla finestra il Prefetto non credeva ai propri occhi: circa 40.000 tra contadini e tabacchine gremivano le piazze e le strade dell’aureo barocco di Lecce.
************************************************************************
I contadini e le tabacchine si spaccavano le braccia, le ossa, la schiena: la terra arida dava magre ricompense. La campagna povera del sud dell’Italia doveva diventare una civiltà alla scuola della fame e della dignità.
Bisognava far capire che il lavoro era una condizione collettiva, tanto più dignitosa quanto più il capitale ed il lavoro (i due fattori classici della produzione) erano remunerati con equilibrio e bilanciamento.
Ma non era facile: chi per paura di perdere anche quel poco che aveva, chi per pigrizia, chi per ignoranza, chi per quieto vivere, pur accettando in linea di principio quelle istanze, difficilmente si esponeva in prima persona rivendicando ciò che gli spettava.
Proprio per questo, per il contesto da vera e propria cappa feudale, il merito della Isa va raddoppiato. Anzi decuplicato.
************************************************************************
La lotta e la passione della Isa dovrebbero camminare oggi sulle nostre gambe. Altrimenti sarebbe inutile questa sera starne qui a parlare. Ecco: la democrazia è una conquista giornaliera. Mai definitiva!
La fissità arcaica di rapporti sociali fondati sull’abuso della vita non è poi così lontana dai nostri tempi. Chi ha sfogliato L’Espresso di qualche settimana fa, allorché si parlava dei nuovi schiavi, avrà avuto modo di capire che proprio nella nostra Puglia, nei nostri campi c’è una realtà feroce, che non ama i riflettori, ma che non deve faticare tanto per nascondersi...
Il caporalato non è un cimelio antico, rispolverato in occasione di una coraggiosa inchiesta giornalistica: è invece una miscela nauseabonda di lavoro nero e criminalità, anche mafiosa. E non c’è differenza se il lavoratore è pugliese o extracomunitario o se è un contadino di colore schiavizzato nella raccolta dei pomodori del foggiano, o una badante dell’est europeo sottopagata e senza orari di lavoro.
************************************************************************
Oggi si assiste tra l’altro a fenomeni strani che colpiscono molti lavoratori dipendenti, “invitati” a lavorare così tanto da stravolgere il senso stesso della natura del lavoro, che è mezzo e non fine della vita.
Approfondendo la ricerca si scopre che la giornata lavorativa di 10 o 12 ore sta diventando (oggi, 2006!) per molti un’eccezione sempre più rara: “capireparto” di ipermercati impegnati per circa 72 ore settimanali, senza contare le eventuali domeniche; brillanti laureati cooptati da multinazionali di consulenza aziendale, che dopo i massacranti turni settimanali, sono costretti a portarsi il lavoro a casa (per “terminare la relazione nel week-end”). E, sia chiaro, spesso non si hanno alternative.
************************************************************************
Per carità: io sono il primo a rimproverare il giovane, magari trentenne, mammone e pigro, che oggi si aspetta la manna dal cielo, il posto di lavoro scodellato bello e pronto e a tempo indeterminato, solo perché “ha studiato”.
Penso che gli anni di gavetta siano necessari, per tutti. Aggiungo perfino (e lo dico con coraggio in questa assise di sindacalisti!) che una quota di “sfruttamento”, allo scopo di imparare un mestiere, debba essere messa in conto… Ma una cosa è dire questo, un’altra è pensare di mantenere la “competitività aziendale” attraverso codeste inqualificabili politiche gestionali. Politiche che ovviamente non vengono mai chiaramente esplicitate: nessuno ti chiede palesemente di passare la vita dentro l’azienda; nessuno ti obbliga a rimanere fino a sera; devi solo saperti organizzare e raggiungere gli obiettivi prefissati…
Ma in questo modo tu sei solo contro il mondo intero!
La corsa frenetica verso il profitto spinge l’uomo a calpestare la dignità di un suo simile, che poi è un suo “collega”. Il lavoro è un diritto di cittadinanza, non una merce grezza di scambio!
************************************************************************
Chiudendo la parentesi e ritornando al nostro tema diciamo che la Palumbo (per dirla con il nostro presidente Nichi Vendola) era “rea di porto abusivo di sogno”.
Anzi aggiungiamo dicendo che tendenzialmente era colpevole e recidiva. Viveva in una realtà da incubo ma nutriva il sogno in cui le persone sono finalmente più importanti delle merci e dei soldi.
Se non ci fossero stati i capipopolo come la Isa oggi saremmo ancora alla condizione dei dipendenti dell’800, quelli della prima rivoluzione industriale. La lotta non serve ad un solo bracciante o ad un operaio; quell’unione serviva (e serve) al benessere di tutti.
************************************************************************
La Isa ora riposa in pace nella cappella di famiglia nel cimitero di Noha. Intorno alla sua tomba in primavera ho visto crescere spontanei gruppi di papaveri rossi. E ci stanno bene.
************************************************************************
Non so che rapporto con Dio o con la trascendenza possa la Isa aver avuto.
Mi pare che fosse atea, o scettica, o agnostica, o comunque una cristiana non praticante; ma di lei ammiravo la fede profonda nella continuità della vita, il senso assoluto del dovere, quello che ha spinto molti non credenti, anche altrove nel mondo, alla tortura pur di non tradire gli amici, o altri ancora a farsi appestare per guarire gli appestati: è questo il “lasciare il messaggio nella bottiglia”, perché in qualche modo quello in cui si credeva, o che sembrava bello, possa essere creduto o appaia bello a coloro che verranno.
La Isa, forse, potrà pur non aver avuto esperienza di trascendenza, ovvero l’abbia perduta, ma credo che si sarà sentita confortata dall’amore per gli altri e dal tentativo di garantire a qualcun altro una vita vivibile anche dopo la sua scomparsa. Sono questi gli spiriti grandi quelli che aiutano l’umanità a crescere e diventare più giusta e civile.
************************************************************************
Così concludeva la Isa (e concludo anch’io) la sua intervista a Luigi del Prete, ripresa per il citato documentario sulle tabacchine: “Finchè ci sarà il ricco che può comprare ed il povero che si fa comprare non ci sarà giustizia. E quei pochi che vogliono uscire da questa oppressione ci rimettono la pellaccia!...”.
E ancora: “Oggi la donna del Salento e degli altri paesi, l’emancipazione l’intende nelle calze di nailon, nel cappotto di pelliccia, nella macchina… Ma la vera emancipazione non è questa. In questi termini l’emancipazione… non c’è! Ma la vera emancipazione è chiedersi: chi sono io, che cosa posso dare alla vita, che cosa posso ricevere dalla vita…”.
************************************************************************
Ecco: la Isa potrebbe pur aver avuto tutti i difetti di questo mondo, ma basterebbero queste ultime sue parole per erigerLe un monumento alto fino al cielo!
lug272018
 Finalmente, come ogni outing che si rispetti, ho trovato il coraggio di confessarlo al mondo intero: ebbene, quando ero piccolo, i miei coltivavano il tabacco e io con loro.
Finalmente, come ogni outing che si rispetti, ho trovato il coraggio di confessarlo al mondo intero: ebbene, quando ero piccolo, i miei coltivavano il tabacco e io con loro.
Sapete, l’infanzia è come certe pietanze che pensi tu abbia digerito ma quando meno te l’aspetti tornano su.
In genere si dice che la puerizia sia il periodo più bello della nostra vita. Sì, va bene, io ne ho avuto una sostanzialmente tranquilla, due ottimi genitori, e la tragedia non è mai andata al di là di uno scappellotto altrimenti detto mappina.
Ebbene, io credo che non esista età più disperata, terribile e disgraziata di quella in cui la tua occupazione principale è quella di provare a diventare un uomo: qualsiasi cosa tu faccia spontaneamente non è mai quella giusta, e devi dipendere di continuo dal giudizio, dalle prescrizioni e dagli orari degli altri (anche se questi altri ti amano alla follia).
 Se poi a questa infanzia, già di per sé drammatica, tu ci aggiungi pure il tabacco capite il livello di crudeltà.
Se poi a questa infanzia, già di per sé drammatica, tu ci aggiungi pure il tabacco capite il livello di crudeltà.
Insomma, odiavo con tutto il cuore la coltura fumogena del tabacco: che non rientrava punto nei miei orizzonti lavorativi, non dico come impiego ma nemmeno come ripiego.
Meno male che allora non esisteva il Telefono Azzurro, altrimenti ne avrei intasato le linee con le mie continue richieste di aiuto. Certo, non avrei nemmeno saputo come fare visto che non possedevo né un telefonino portatile (che era ancora in mente dei), e nemmeno quello fisso di casa, che arrivò intra-moenia qualche decennio più tardi. Per farvi comprendere il contesto, e visto che siamo in tema di Outing, aggiungo che in quel periodo avevo pure una zita di Bolzano, una ragazza bellissima conosciuta al mare. Ci scrivevamo lunghe lettere. Eh sì, altri tempi. Tempi d’attesa, dico. Sicché il postino non fece in tempo a recapitarmi l’ultima lettera in cui la mia adorata asseriva di amarmi alla follia, che la medesima era già bellamente convolata a nozze. Oltretutto felici.
Ma cerchiamo di ritornare sui filari ché le divagazioni potrebbero portarci fuori dai semenzai.
 La coltivazione di codesto maledetto tabacco aveva inizio in pieno inverno, durante il mese di febbraio. Si iniziava con le ruddhre (i semenzai, appunto), che spesso erano ricoperte da un telo onde evitare che le gelate potessero colpirne le piantine. Io, fra tutti gli dei dell’Olimpo, pregavo con particolare zelo il loro capo Zeus affinché su quelle ruddhre scagliasse il suo fulmine: che da noi si chiamava sajetta.
La coltivazione di codesto maledetto tabacco aveva inizio in pieno inverno, durante il mese di febbraio. Si iniziava con le ruddhre (i semenzai, appunto), che spesso erano ricoperte da un telo onde evitare che le gelate potessero colpirne le piantine. Io, fra tutti gli dei dell’Olimpo, pregavo con particolare zelo il loro capo Zeus affinché su quelle ruddhre scagliasse il suo fulmine: che da noi si chiamava sajetta.
Le ruddhre dovevano essere annaffiate, curate e ripulite dalle fastidiose erbette. È inutile aggiungere che io tifavo e tifo tuttora per ogni tipo di erba, inclusa la gramigna, che qualche stolto – non avendo ancora capito il concetto di biodiversità – continua a chiamare erbacce (e che per il timore della povera sputacchina vorrebbe diserbare non so più con quali portentosi veleni chimici).
Tra aprile e maggio, quando le piantine (la chiantìma) erano pronte si procedeva al loro reimpianto negli interminabili (in lunghezza) e infiniti (in larghezza) filari di tabaccare.
Le varietà coltivate erano i tabacchi orientali: Erzegovina, Perustitza e Xanti Yaca. Vi risparmio le differenze tra le tre qualità di tabacco che conosco meglio di ogni perito in scienze agrarie con specialistica nel settore.
Nei giorni successivi bisognava procedere a innaffiare la piantagione e ovviamente a sarchiarla spaccandosi la schiena. Di questo però si occupava quel sant’uomo di mio padre: io ne ero dispensato per via della scuola (ubi maior). Verso la metà del mese di giugno, appena subito dopo la festa del Taumaturgo di Padova, in piene vacanze nohane, iniziava la mia specialissima campagna di Russia, con la differenza delle temperature e con il parallelo di un solo caduto sul campo di battaglia: il sottoscritto.
Vi confido che dunque disdegnavo il 13 giugno, giorno del mio onomastico, foriero della mia incipiente estate calda, triste e infausta. Tanto che mi venivano automaticamente i lucciconi agli occhi allorché, tra gli applausi dei parenti, ero chiamato al taglio della torta di Sant’Antonio. Ma non erano mica lacrime di commozione quelle, bensì di dolore vivo per quello che m’aspettava nei giorni a seguire e fino al tanto sospirato mese di settembre.
 Dopo la solennità di questo Santo dispensatore di miracoli (agli altri, mica al sottoscritto), iniziavano le danze. Da lì a poco venivo ridotto in schiavitù da questa mala pianta importata dall’America. E voi non immaginate quante volte ho inveito contro quel rompicoglioni di Cristoforo Colombo, che aveva osato, per giunta per isbaglio, di scoprire il Nuovo Mondo e dunque il tabacco, rovinandomi così le mie estati salentine.
Dopo la solennità di questo Santo dispensatore di miracoli (agli altri, mica al sottoscritto), iniziavano le danze. Da lì a poco venivo ridotto in schiavitù da questa mala pianta importata dall’America. E voi non immaginate quante volte ho inveito contro quel rompicoglioni di Cristoforo Colombo, che aveva osato, per giunta per isbaglio, di scoprire il Nuovo Mondo e dunque il tabacco, rovinandomi così le mie estati salentine.
[continua]
Antonio Mellone
dic102006
Da 'il Galatino', anno XXXIX, n. 21, dell'8 dicembre 2006, per la solita penna di Antonio Mellone, leggiamo la storia del tabacchino di Noha. Ve la proponiamo in tre parti, o, se preferite, in tre puntate settimanali. Anche questo è un contributo per la conoscenza della nostra bella cittadina e della sua storia economica.
IL TABACCHINO DI NOHA
(prima parte)
Abbiamo già detto, e qui lo ribadiamo ancora una volta, che nel nostro recente libro “Noha. Storia, arte, leggenda” (Infolito Group, Milano, 2006; scritto a quattro mani con il P. Francesco D’Acquarica), benché voluminoso, per ovvie considerazioni non abbiamo potuto esporre e citare, rispetto a quanto già fatto, numerose altre storie, esaminare mille altre aziende, parlare di tutti i personaggi di Noha (posto che sia possibile conoscere tutti i personaggi di un luogo, per quanto piccolo questo possa essere)…
Qualcuno ancora oggi ci ferma per strada e ci ricorda le nostre “omissioni”.
Ma eravamo ben consapevoli di questo sin dal principio del lavoro (ed in alcuni brani del testo lo abbiamo anche ripetuto): chissà quante altre cose o accadimenti o soggetti o artisti sono rimasti nelle nostre penne (o nei tasti dei nostri computer). E chissà quanto ancora ci sarà da scoprire, studiare, riscrivere, ripensare, confutare (anche!), gli argomenti o i temi che nel suddetto libro s’è trattato soltanto superficialmente o non s’è trattato affatto.
In questo intervento tratteremo, dunque, di uno di codesti “omissis”, che, volendo, potrà essere conservato come foglio volante, da inserire tra le pagine del summenzionato tomo: stiamo parlando del “tabacchino di Noha”.
Il tabacchino era ed è forse il negozio più diffuso in Italia. Già sin dagli inizi del secolo scorso, anche a Noha, proprio in piazza San Michele ce n’era uno condotto da tale Ciccio Liguori, ma molti non lo ricordano quasi più…
L’altro invece che affiora nella memoria di più di un giovanotto dalla manifesta canizie era il tabacchino ubicato all’angolo tra la piazza San Michele e la via Castello, là dove oggi è situata la sede dei Democratici di Sinistra (già sezione del Partito Comunista Italiano).
In quell’angolo c’era un negozietto: il tabacchino di don Lisandro (Alessandro) e di donna Elvira. Don Lisandro e consorte, che abitavano in una stanza al piano superiore della loro bottega, vendevano i prodotti dei Monopoli di Stato come sale da cucina, e tabacco: tabacco da pizzico (da fiuto), sicàri (sigari), tabacco trinciato per la pipa e finanche tabacco da masticazione e le prime sigarette confezionate, che però rappresentavano solo l’eccezione: la maggior parte dei tabagisti, infatti, fumava sigarette autoprodotte artigianalmente, attraverso l’uso delle cartine contenenti tabacco sfuso, tagliuzzato e non lavorato.
In quel tabacchino trovavi anche capisciòle, bottoni e bucàte, bavette per i piccinni, spolette di cotone bianco o colorato. In un lato del negozietto, don Lisandro, per arrotondare, esponeva per la vendita anche coppole, cappelli, berretti e copricapo di ogni taglia (ma senza troppa scelta di forme o colori: non c’erano ancora le sfilate di moda e le griffes dei giorni nostri).
Poi (gli anni pesano a tutti) don Lisandro lasciò; sua figlia Edda “sposò a Gallipoli”, andò a vivere nell’amena città ionica ed il negozio fu chiuso.
Fu riaperto subito dopo, sempre nel cuore di Noha, da Luigi Mazzotta (Cici), originario di Galatina e da sua moglie Antonietta (Tetta): e fu così inizio di tre generazioni di tabaccai, come diremo.
ANTONIO MELLONE
set182023
Finalmente dopo la tempesta di annunci, video, post, dubbi esistenziali, qualche excusatio non petita e un’infinità di comunicati ufficiali, arrivò la quiete. È bastato un brain storming prefettizio per trovare il bandolo della matassa, svelare la soluzione al giallo, individuare il colpevole di quegl’impercettibili problemi di accesso al parterre del concertone dei Negramaro 20 Years Old: genetliaco celebrato all’aeroporto militare di Galatina a botte di 50/70 euro a cranio, bevande e parcheggio esclusi. 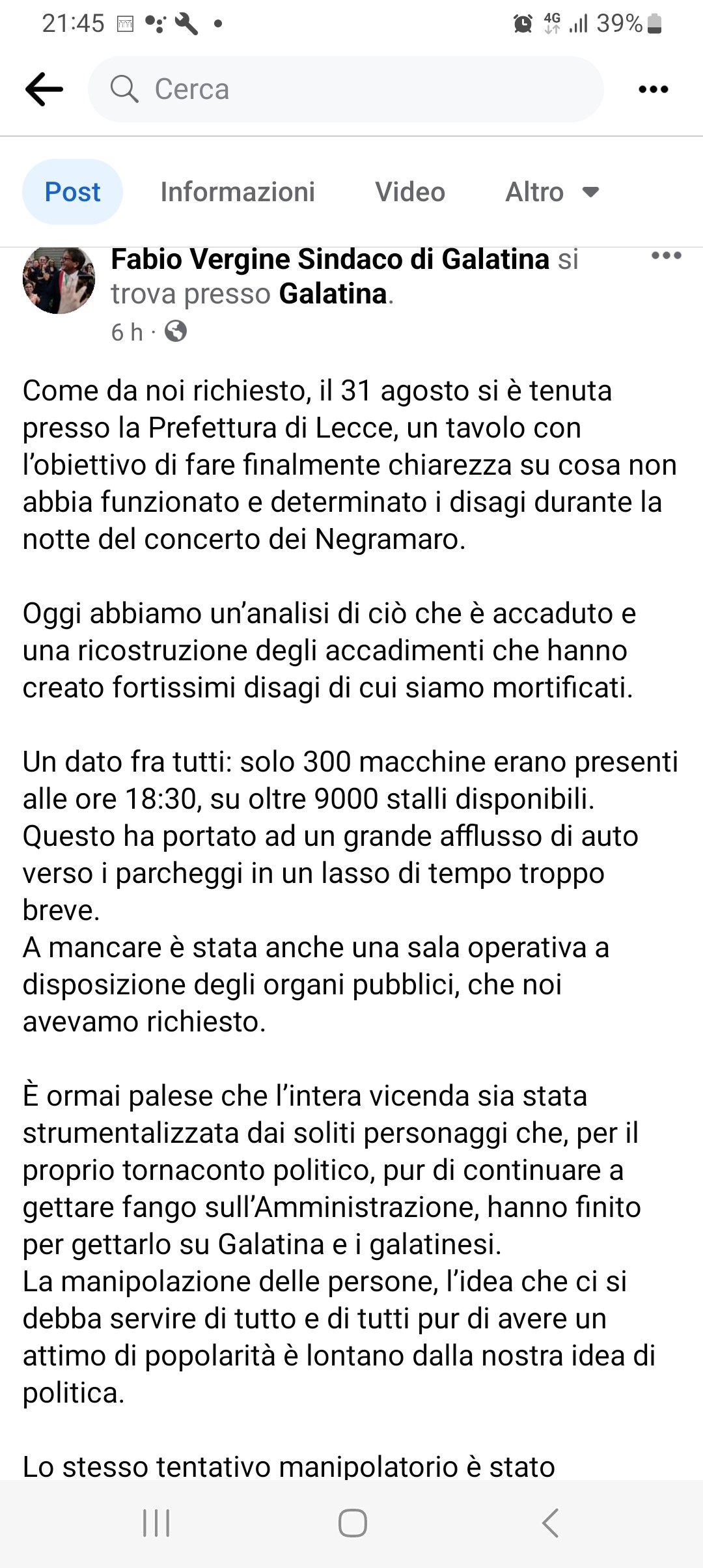 A spiattellare l’arcano il nostro sindaco (membro del suddetto trust di cervelli), il quale, petto in fuori e pancia in dentro, con “orgoglio ed emozione” - come quando riceve tutto in ghingheri il ministro della guerra Crosetto (“Un uomo in grado di scaldare i cuori” [sic]) - con un epico ma viepiù lirico post sulla sua pagina ufficiale, rimanendo serio dichiara: “Il 31 agosto si è tenuta [sic] presso la Prefettura di Lecce un tavolo con l’obiettivo di fare finalmente chiarezza su cosa non abbia funzionato […]. Oggi abbiamo un’analisi di ciò che è accaduto e una ricostruzione degli accadimenti […]”. In parole povere e in estrema sintesi: “Un dato fra tutti: solo 300 macchine erano presenti alle 18.30 su oltre 9000 stalli disponibili. Questo ha portato un grande afflusso di auto verso i parcheggi in un lasso di tempo troppo breve. […]”. Per chi non conoscesse l’aramaico moderno codesti profondi pensierini tradotti in italiano suonano più o meno così: la colpa è tutta di quegli “ospiti” a pagamento che non si sono svegliati prima, e a migliaia hanno intasato le strade e le carrare di accesso all’aeroporto all’ultimo minuto, gridando poi allo scandalo. Fossero partiti il giorno avanti, oppure la mattina presto alla solita ora della raccolta del tabacco in quegli stessi campi, o al più subito dopo pranzo, sacrificando per una volta nella loro vita la siesta pomeridiana, tutto ‘sto casino non sarebbe successo, e noi altri probiviri ci saremmo risparmiati intasamenti, recriminazioni, commenti disperati sui social, la figura di deiezione planetaria associata a “Galatina mia”, nonché il ritardo di un’oretta all’inizio del concerto Meraviglioso. E mo’ con tanto di class action chiedono indietro i soldi dei biglietti e probabilmente pure il risarcimento dei danni, ‘sti marrani che non sono altro, digiuni dei più elementari principi del darwinismo sociale. Invece è dettaglio di secondaria importanza, senz’altro un’inezia, il fatto che se tutti i 25 mila “aspettatori” si fossero presentati ai cancelli alle 18.30 si sarebbe corso il rischio di dover rinviare lo spettacolo della band salentina dal ventennale al trentennale.
A spiattellare l’arcano il nostro sindaco (membro del suddetto trust di cervelli), il quale, petto in fuori e pancia in dentro, con “orgoglio ed emozione” - come quando riceve tutto in ghingheri il ministro della guerra Crosetto (“Un uomo in grado di scaldare i cuori” [sic]) - con un epico ma viepiù lirico post sulla sua pagina ufficiale, rimanendo serio dichiara: “Il 31 agosto si è tenuta [sic] presso la Prefettura di Lecce un tavolo con l’obiettivo di fare finalmente chiarezza su cosa non abbia funzionato […]. Oggi abbiamo un’analisi di ciò che è accaduto e una ricostruzione degli accadimenti […]”. In parole povere e in estrema sintesi: “Un dato fra tutti: solo 300 macchine erano presenti alle 18.30 su oltre 9000 stalli disponibili. Questo ha portato un grande afflusso di auto verso i parcheggi in un lasso di tempo troppo breve. […]”. Per chi non conoscesse l’aramaico moderno codesti profondi pensierini tradotti in italiano suonano più o meno così: la colpa è tutta di quegli “ospiti” a pagamento che non si sono svegliati prima, e a migliaia hanno intasato le strade e le carrare di accesso all’aeroporto all’ultimo minuto, gridando poi allo scandalo. Fossero partiti il giorno avanti, oppure la mattina presto alla solita ora della raccolta del tabacco in quegli stessi campi, o al più subito dopo pranzo, sacrificando per una volta nella loro vita la siesta pomeridiana, tutto ‘sto casino non sarebbe successo, e noi altri probiviri ci saremmo risparmiati intasamenti, recriminazioni, commenti disperati sui social, la figura di deiezione planetaria associata a “Galatina mia”, nonché il ritardo di un’oretta all’inizio del concerto Meraviglioso. E mo’ con tanto di class action chiedono indietro i soldi dei biglietti e probabilmente pure il risarcimento dei danni, ‘sti marrani che non sono altro, digiuni dei più elementari principi del darwinismo sociale. Invece è dettaglio di secondaria importanza, senz’altro un’inezia, il fatto che se tutti i 25 mila “aspettatori” si fossero presentati ai cancelli alle 18.30 si sarebbe corso il rischio di dover rinviare lo spettacolo della band salentina dal ventennale al trentennale.
 Qualche giorno dopo, passato lo santo (cioè Sangiorgi: ché i gabbati sono altri), il nostro primo cittadino, sciogliendo inni e canti al santissimo e divinissimo assembramento, pubblica sul suo profilo fb una foto di piazza San Pietro sovraffollata grazie alle ronde della Notte della Taranta, immagine irrobustita dall’immancabile slogan motivazionale: “La città è sempre più viva”. Non so voi, ma io mi sento già meglio - e meno male che il ridicolo non ha mai ammazzato nessuno, se no a Galatina saremmo un giorno sì e l’altro pure con la bandiera a mezz’asta per lutto cittadino.
Qualche giorno dopo, passato lo santo (cioè Sangiorgi: ché i gabbati sono altri), il nostro primo cittadino, sciogliendo inni e canti al santissimo e divinissimo assembramento, pubblica sul suo profilo fb una foto di piazza San Pietro sovraffollata grazie alle ronde della Notte della Taranta, immagine irrobustita dall’immancabile slogan motivazionale: “La città è sempre più viva”. Non so voi, ma io mi sento già meglio - e meno male che il ridicolo non ha mai ammazzato nessuno, se no a Galatina saremmo un giorno sì e l’altro pure con la bandiera a mezz’asta per lutto cittadino.
Non paghi della precedente toppa a colori leggermente peggiore del buco e per dire quanto le profezie di Orwell sembrino scadenti imitazioni della realtà, il 24 agosto scorso giunge bel bella delibera unanime di giunta d’incarico a un avvocato per un’“espletanda attività sostanziantesi nella preliminare valutazione di sussistenza degli estremi per la presentazione di denuncia-querela e, accertati i presupposti, nella predisposizione e deposito presso la Procura della Repubblica di Lecce, del predetto atto” [mo’ ditemi voi se il titolare di codesta prosa da ipossia nel povero lettore non meriterebbe i domiciliari, o quanto meno l’immediata iscrizione nel registro degli indagati, ndr.]. In pratica l’occhiuta sorveglianza avvocatesca sarà tutta volta a esaminare articoli, messaggi, commenti, attributi, epiteti, locuzioni, lemmi, virgole e punti esclamativi “propalati a mezzo internet”, per spezzare le reni ai tiratori scelti di fango, vale a dire chiunque osi parlare in termini men che lusinghieri del concerto, della comunicazione del locale Istituto Luce (meglio noto come Istituto Corso Porta Luce), e di tutto l’ambaradan negramarognolo. Eh sì signora mia: dobbiamo tutelare l’immagine della città con un bel po’ di querele: ché noi siamo buoni e cari, ma quando ci toccano l’immagine di “Galatina mia” apriti cielo. E mi raccomando, nessuna scriminante per la satira, nonostante a suo tempo fossimo tutti Charlie Hebdo.
 Tra l’altro 800 euro di stanziamento in bilancio per il nobile proposito della censura mi sembrano un affarone: e dove altro riusciresti a portare a casa, chessò io, 100 denunce a 8 euro cadauna? Ma fossero pure 10 a 80 euro, sarebbero già saldi di fine stagione, prezzi da stock, 3X2, e fuori tutto. A meno che non si decida di applicare il principio “Unum castigabis, centum emendabis” (colpirne uno per educarne cento), e chissà che quell’Unum non venga scelto magari con estrazione a sorte, ovvero tramite vaglio di titoli ed esami. E vuoi vedere che il fortunato vincitore (non chiamatela eterogenesi dei fini) sarà proprio chi si mette a vergare certi comunicati istituzionali, a volte indugiando sul proprio ombelico e di tanto in tanto minacciando processi per lesa maestà. O forse lessa maestà.
Tra l’altro 800 euro di stanziamento in bilancio per il nobile proposito della censura mi sembrano un affarone: e dove altro riusciresti a portare a casa, chessò io, 100 denunce a 8 euro cadauna? Ma fossero pure 10 a 80 euro, sarebbero già saldi di fine stagione, prezzi da stock, 3X2, e fuori tutto. A meno che non si decida di applicare il principio “Unum castigabis, centum emendabis” (colpirne uno per educarne cento), e chissà che quell’Unum non venga scelto magari con estrazione a sorte, ovvero tramite vaglio di titoli ed esami. E vuoi vedere che il fortunato vincitore (non chiamatela eterogenesi dei fini) sarà proprio chi si mette a vergare certi comunicati istituzionali, a volte indugiando sul proprio ombelico e di tanto in tanto minacciando processi per lesa maestà. O forse lessa maestà.
Antonio Mellone
ott302020

Per somiglianza di suoni Sìrgole rievoca un po’ Frìttole - il borgo di “Non ci resta che piangere”, film del 1984 con Troisi e Benigni - ma è una tenuta, meglio, la denominazione di una contrada del feudo di Cutrofiano frequentata da molti nohani e altrettanti galatinesi, tra i quali mio papà Giovanni che ne ha coltivato un pezzo per una vita, coinvolgendo per un tratto e suo malgrado (nel senso di mio malgrado) il sottoscritto: erano i tempi infausti del tabacco, un’era geologica fa. Oggi ce lo porto io, mio padre, insieme ai suoi 97 anni a far due passi, a prendere aria, a “sbariare” un po’.
Ebbene, ogni volta che vado a Sìrgole torno a casa sempre con qualcosa di buono. A seconda della stagione, i gelsi, i peperoncini e le melanzane, l’uva, i kaki e i kiwi (con questa k che sa di esotico), e le cicorie che oggi coltivano i miei cugini di campagna; ma anche le “creste” (sempre nel senso di cicorie) che la terra ci dona sua sponte. A volte tra le produzioni fresche e genuine abbiamo pure i libri (ché cultura e agricoltura sono sempre andate a braccetto). Questi ultimi non me li passano i suddetti cugini, ma, copiosi, dunque con la carriola, i vicini di campagna: o meglio, il vicino che risponde al nome di Gianluca Virgilio, professore di lettere al liceo scientifico di Galatina, conosciuto ormai da tutti perché da anni scrive su “il Galatino”, e pure un bel po’ di libri - alcuni addirittura tradotti in francese (non vedo l’ora di rileggerli in quest’altra lingua romanza).
 Questa volta il fragrante tomo “virgiliano”, letto come d’abitudine nell’arco di due pomeriggi, è “Zibaldone Salentino”, Edit Santoro, Galatina, 2020, 150 pagine, quasi omonimo della rubrica (cambia solo l’aggettivo in “galatinese”) tenuta, appunto, su questo giornale. Si tratta di un tipico prodotto a km 0, giacché è stato certamente pensato nel corso di letture sotto il pergolato, annaffiature di piantine e sfalcio di erbe, e dunque scritto, benché rapsodicamente, sempre a Sìrgole, “campagna ricca di sogni”, onde finalmente podere è potere.
Questa volta il fragrante tomo “virgiliano”, letto come d’abitudine nell’arco di due pomeriggi, è “Zibaldone Salentino”, Edit Santoro, Galatina, 2020, 150 pagine, quasi omonimo della rubrica (cambia solo l’aggettivo in “galatinese”) tenuta, appunto, su questo giornale. Si tratta di un tipico prodotto a km 0, giacché è stato certamente pensato nel corso di letture sotto il pergolato, annaffiature di piantine e sfalcio di erbe, e dunque scritto, benché rapsodicamente, sempre a Sìrgole, “campagna ricca di sogni”, onde finalmente podere è potere.
Il titolo del libro, ça va sans dire, è un omaggio a Giacomino nostro, che al suo “scartafaccio” attribuì gli aggettivi di “smisurato” e “immenso” (io ci aggiungerei “superbo”, molto usato dal Leopardi nell’accezione di magnifico e grandioso, e giammai di protervia o spocchia), tipici del Pensiero: il quale o è critico - dunque senza limiti timori o altre siepi che il guardo escludono - o non è. Purtroppo codesto pensiero è oggi, come dire, negletto, quando non spinto sul banco degli imputati, non necessariamente da una querela temeraria, ma proprio dal comune sentire, dall’uniformazione globale falsamente pluralista, dall’omologazione a senso unico.
Ciononostante vale la pena di provare esprimerlo, questo pensiero (o questo spirito), anche a costo di spaccare il capello in quattro e apparire antipatici alla massa ondivaga a seconda di dove spira il vento del marketing, vale a dire la propaganda da parte della classe dominante. E così nascono le pagine di questo diario senza tempo che ti fa riflettere sulle parole, tipo “successo”, una cosa a cui molti ambiscono ma che altro non è che un participio passato; sul senso della vita, che visto che è a scadenza val la pena di trattarla con più ironia e distacco; sullo spreco delle migliaia di case vuote, mentre tutto intorno le betoniere continuano rovesciare cemento sui comparti edilizi senza fine; sul ruolo dell’insegnante e quindi della scuola che non dev’essere un luogo dove “si formano e si valutano gli studenti”, bensì un posto dove “dialogare e stare a vedere”; sulla violenza del capitalismo, che fa rima con cannibalismo, suicidio dell’umanità; sul ruolo della tecnologia che ci sta spingendo verso il distanziamento sociale ante-litteram; su quanto la mia ricchezza non valga nulla se il mio dirimpettaio sta male; sul Panem et circenses quale metodo di inquadramento delle masse; su quanto il potere si serva dell’inganno per raggiungere i suoi obiettivi; sul Neo-Barocco, che è quello della nostra epoca, così pervasa dalla “gentrificazione” dei centri storici, dallo scimmiottamento della pizzica e dai riti vuoti del turismo; e su infiniti altri temi tipici di uno Zibaldone.
Scrive bene Gianluca, avrà preso da suo padre, il compianto prof. Giuseppe Virgilio. Lo stesso giorno in cui mi consegnava la sua novella creatura – guarda la combinazione - terminavo di rileggere, di Giuseppe, lo stupendo “Memorie di Galatina” - Congedo Editore, Galatina, 1998 - che consiglio vivamente. A Noha si dice: “L’arte de lu tata è menza ‘mparata”, ovvero “Sotta ‘nu pannu finu c’è ‘naddhru ‘ncora chiù finu”.
Credo non ci sia bisogno del traduttore di Google perché si colga il senso di questi apoftegmi nohani anche a Galatina.
Antonio Mellone
[articolo pubblicato su “il Galatino”, anno LIII, n. 17 – 23 ottobre 2020]
nov302007
- Il tabacco
- Gli Ulivi
- La Vendemmia
- Il Maniscalco
Scarica il Flash Player per visualizzare il Filmato.
apr302009

Tarantismo, snobismo e ragnatela
Alla festa patronale di Galatina, quella di fine giugno dedicata ai Santi Pietro e Paolo, i giovanotti di Noha partecipavano raramente. Infatti molti di loro, poco più che imberbi ragazzini - incluso il sottoscritto - erano fin dai primi del mese “ritirati in campagna” dove nel corso dell’estate avrebbero dedicato tutto il loro tempo e le loro energie al giogo opprimente del tabacco, cui la famiglia tutta era dedita con il suo diuturno lavoro per guadagnarsi da vivere. Dunque la fine della scuola rappresentava per noi altri tutto men che l’inizio di una bucolica villeggiatura! Solo uno sparuto numero di compagni di classe che si poteva contare sulle dita di una sola mano aveva la possibilità di partecipare alla festa patronale di Galatina, che sempre ci veniva descritta come imponente, maestosa e particolare. La particolarità stava nel fatto che, come ci raccontavano, l’ultimo giorno della festa, solennità di San Paolo, in una cappellina prospiciente piazza San Pietro avveniva con una precisione cronometrica “dalle ore 12 alle ore 13” il miracolo della guarigione delle tarantate. Erano queste delle persone strane, soprattutto donne, che incappate nel morso della tarantola, si dimenavano distese per terra, saltellavano e ballavano anche sull’altare della chiesetta, e spesso rincorrevano uno o più astanti curiosi (soprattutto chi indossava abiti di color rosso), creando un fuggi-fuggi generale nel pubblico che sempre numeroso si accalcava a ronda in quell’intorno.
Le tarantate non erano mai di Galatina (molte venivano dal Capo di Leuca). E nemmeno a Noha vi erano tarantate, né ve ne erano mai state in passato. Pare che per grazia di San Paolo, Galatina ed il suo “feudo” godessero del privilegio dell’”immunità” dal tarantismo.
Del resto Galatina ha sempre visto il tarantismo come un corpo estraneo, un fenomeno da osservare dall’esterno, forse dall’alto. E’ come se non ne fosse condizionata culturalmente. Erano gli altri, i “forestieri”, a dover rispettare una tradizione, a dover ripetere un rito stagionale, a doversi recare in pellegrinaggio a bordo dei loro sciarabbà in quel territorio “sacro” per celebrare una cerimonia salutare. I galatinesi erano solo degli spettatori, perlopiù distratti. L’immunità era anche un non volersi sporcare le mani, un fastidio, e se vogliamo una cosa da raccontare agli altri con vergogna, più che con pudore dettato da compassione.
Galatina si è sempre sentita città borghese, sede di banche e di palazzi gentilizi con tanto di stemma nobiliare, di proprietà dei ben pasciuti agrari. Quegli agrari che magari avevano usato ed abusato del lavoro e della dignità di quei contadini, tra le cui fila appunto nascevano le tarantate ed i connessi traumi, frustrazioni e conflitti irrisolti.
Quell’immunità nel corso degli anni si è trasformata nella peggiore delle forme di comunicazione e di contatto: lo snobismo. Una brutta parola che in dialetto si tradurrebbe anche con “garze larghe” o qualcosa di simile.
Per anni molti galatinesi hanno aborrito le serate di pizzica-pizzica che iniziavano a macchia di leopardo a celebrarsi un po’ in tutto il Salento. Questo fino a quando non arrivò, ormai oltre un decennio fa, quel laboratorio culturale di musica e di pensiero, quell’esperienza straordinaria che risponde al nome di “La Notte della Taranta”, raduno tra l’altro di altissima qualità, che ha fatto di Melpignano il centro delle manifestazioni della nostra “musica etnica” ormai noto in tutto il mondo. Da Melpignano in poi più di un galatinese si è sentito finalmente “contagiato” dal morso della taranta.
Ma il fatto che Galatina ne fosse (stata) esclusa per tanti anni, crediamo a questo punto che fosse in un certo qual modo naturale, legato alla sua storia.
Ciò che si può fare oggi, allora, non è tanto recriminare, rimpiangere, nutrire rimorsi per ciò che non è stato: la storia si studia, non si giudica. E tanto meno affannarsi per dar corso agli “eventi” scimmiottandone gli altri. L’evento in sé non serve a nulla. Dura lo spazio di una serata o di una giornata. Poi passa e forse non lascia nulla.
Utile sarebbe invece far tesoro di un concetto, anzi di un insegnamento portentosissimo che ci dona proprio il fenomeno del tarantismo: la ragnatela.
La ragnatela è sistema, è equilibrio, è compartecipazione, è un modo per poter “catturare”, diremmo anche affascinare noi stessi e gli altri che ci vengono a trovare.
Galatina è una delle città più belle del mondo. Ma questa è condizione necessaria ma non sufficiente per una buona o ottima qualità della vita. Dovremmo sforzarci un po’ tutti quanti per essere più accoglienti nei confronti dei visitatori, che sempre più numerosi verranno a trovarci. E si è accoglienti se saremo rispettosi intanto verso noi stessi e poi verso gli altri. Si è rispettosi se sapremo aver cura dell’ambiente in cui viviamo, per esempio lasciando un po’ la nostra auto nel garage ed utilizzando di più il nostro cervello per spostarci (dunque a piedi o in bicicletta); se conosceremo la nostra storia riuscendo a farne parte anche agli altri (quanti galatinesi hanno in casa propria il libro “Galatina, storia ed arte” di mons. Antonaci, solo per citare uno dei tanti a caso, pronto per la consultazione?); se riusciremo a dare informazioni anche in inglese o in francese, ma anche in italiano, al viaggiatore straniero che per caso si avvicinasse a noi chiedendocene; se riusciremo ad offrire i nostri prodotti della campagna o dell’artigianato in maniera decorosa e senza rapinarci a vicenda (la pasticceria di Galatina per fare un esempio è la migliore del mondo. Ma non si vende solo il pasticciotto, si vende anche il sorriso ed il buongiorno detto con gentilezza e senza smanceria o sussiego, e questo valga per ogni negozio cittadino. Chiediamocelo tutti: c’è sempre la gentilezza come companatico di ogni transazione galatinese?); se faremo fruire i nostri monumenti tenendoli aperti e con l’assistenza di guide non improvvisate…
Le occasioni per renderci più accoglienti e disponibili sono mille e ancora mille. E si potrebbero riassumere nello sforzo per renderci migliori, meno spocchiosi, meno mafiosetti, più responsabili.
Ma per tutto questo c’è bisogno di molto studio, molta formazione, molto tempo.
La ragnatela è il vero ed il miglior prodotto del tarantismo. Dovremmo tutti impegnarci a tesserla.
Antonio Mellone
ago062016
Nel corso del solleone estivo, precisamente il 7 di agosto, ricorre la solennità di San Donato. E quindi l’onomastico del fu don Donato Mellone (1925 -2015). Quella che segue è una delle sue (inedite)“omelie di San Donato” trovate di recente nell’archivio dell’antico parroco di Noha. Non vi è riportato l’anno al quale lo scritto si riferisce: dalle prime battute si arguisce soltanto che quell’anno il 7 agosto cadeva di domenica.
*
I chierichetti, salvo quelli che “si ritiravano” in campagna, continuavano a frequentare la parrocchia anche d’estate (don Donato soleva ripetere che la chiesa è come la scuola: “se ti la ‘nnargi’, perdi tutto”).
In compenso, dopo la celebrazione della messa mattutina s’andava tutti al mare.
Alla guida della sua Fiat 128 verde, carica di chierichetti, l’arciprete partiva da Noha verso le otto del mattino e si dirigeva per una breve sosta nella campagna denominata Petrì, sulla via per Collepasso, per “caricare” anche il colà dimorante sottoscritto.
Ricordo che all’inconfondibile suono del clacson di quella benedetta 128 verde che aveva appena imboccato il viale di casa mia (definirla villa sarebbe la più classica delle iperboli) accorrevo come una furia, diciamo per non far aspettare lo zio e gli amici, ma soprattutto per liberarmi finalmente per tutta la mattinata, e fino all’ora del pranzo, dal giogo opprimente del tabacco cui la famiglia tutta era dedita con il suo diuturno lavoro per guadagnarsi da vivere. Altro che bucolica villeggiatura lo scrivente e gli altri figli di contadini trascorrevano nel corso del solleone. Cento volte meglio l’autunno, l’inverno e la scuola.
Da qui ci si dirigeva alla volta del centro di Aradeo dove, in un modesto appartamento ubicato al primo piano di un palazzo prospiciente piazza Camine, abitava il buon don Giovanni Cardinale, collaboratore di don Donato soprattutto nel corso di alcune funzioni, diciamo così, più impegnative tipo funerali o pontificali del vescovo.
Don Giovanni, con i sandali ai piedi e la sua tunica mezzo sgualcita, ci attendeva pronto per salire nella macchina già piena zeppa di gente (si arrivava anche fino a sei o sette chierichetti, oltre ai due sacerdoti) per dirigersi, insieme all’allegra combriccola, alla volta del mare, e precisamente in quella zona di bassa scogliera a sud di Gallipoli denominata “la vecchia torre di Rivabella”. Diciamo qui per inciso che don Giovanni non poteva mancare a questo quotidiano appuntamento: era l’unico fra noi che sapeva nuotare, era l’unica nostra àncora di salvezza, l’unico bagnino se mai ce ne fosse stato il bisogno in quello specchio d’acqua limpido ma, sin dalla riva, profondo.
In quel luogo e in quei tempi, che ricorderò sempre con nostalgia, imparai a nuotare, a raccogliere i ricci in apnea, a fare i primi tuffi, e soprattutto ad amare per sempre il mare del Salento, così bello quando è bello.
Di domenica il mare lo vedevamo invece con il binocolo in quanto i sacerdoti avevano le messe da celebrare, e noi altri chierichetti da servire. Dunque s’andava al mare soltanto nei giorni feriali, a condizione che non ci fosse qualche rito particolare (tipo quello di San Donato, appunto), o il solito matrimonio (rompiscatole) da benedire.
Ora che ci rifletto, credo che con molte probabilità deriverà da qui la mia storica idiosincrasia nei confronti di questo santissimo e divinissimo sacramento.
Antonio Mellone
*
La festa di San Donato quest’anno cade di domenica, e quindi necessariamente è stata soppressa per lasciare il posto alla liturgia domenicale. E’ questo il motivo per il quale le preghiere, come anche le letture, sono quelle della domenica. Però se è stata soppressa la solennità di San Donato, la festa del parroco bisognava celebrarla lo stesso, e lo si sta facendo con i fiori, con le luci, i canti e il suono dell’organo. Penso che non manchi nulla.
Sicché qualcuno o qualcuna, potrebbe dire o pensare dentro di sé: “In fondo vale la pena di essere parroco, perché si ricevono tanti onori”.
Cosa si potrebbe rispondere?
Ebbene, noi rispondiamo dicendo che i festeggiamenti non sono rivolti al parroco, ma a Colui che il parroco rappresenta. E questo è un elemento che bisogna sottolineare, per cui quando si dice che il sacerdote è un uomo come gli altri, si dice la verità; quando si dice che il sacerdote è un peccatore come gli altri, è vero, e il negarlo non sarebbe onesto. Un laico una volta fece questa preghiera: “Signore ti ringrazio ché ci sono dei difetti nel mio parroco, perché se fosse perfetto non riuscirebbe a capire le debolezze e le miserie di noi fedeli”.
E questo è ancora vero. Ma quando si dice che il sacerdote va rispettato s’intende che il rispetto a lui va dato in quanto il parroco è “l’altro Cristo”.
Infatti, mediante la mia umile persona Gesù Cristo ha potuto guidare questa Comunità parrocchiale per tanti anni. Si è servito della mia bocca per parlare, delle mie mani per benedire e consacrare, dei miei piedi per camminare ed avvicinare i malati e i sofferenti, del mio cuore per amare.
Se tutto questo è vero, ed è vero, allora la festa di oggi non è rivolta alla mia persona, ma “a Colui che mi ha mandato”. Il vero parroco, dunque, è Lui. E’ Lui il parroco inamovibile: io sono soltanto un parroco “pro-tempore” (cioè secondo la volontà del vescovo).
E proprio perché la festa non si riduca soltanto ai canti e ai fiori vorrei ricordare a tutti il dovere che abbiamo di pregare per i sacerdoti, e per il parroco in particolare.
Il parroco ogni domenica ha l’obbligo di celebrare la cosiddetta messa “pro-populo”, la messa per il popolo, e quindi anche il popolo ha il dovere di pregare per il parroco. Non solo: ha anche il dovere di collaborare con lui, perché la parrocchia è un organismo vivente, in cui c’è il capo (che è importante), ma anche le membra (che sono parimenti importanti), a condizione che ci sia unione e collaborazione.
Il mio primo pensiero di lode e ringraziamento va dunque a Cristo, che è il nostro capo, e poi anche a voi tutti per la vostra preziosa collaborazione. Ringrazio l’Azione Cattolica, l’Apostolato della Preghiera, le altre associazioni religiose, i collaboratori del catechismo, il gruppo canto, le signore che danno una mano nella pulizia della chiesa, e tutti gli altri uomini e donne di buona volontà.
Vi esorto a perseverare nel vostro lavoro in questa comunità.
Un parroco che presumesse di fare tutto da solo sarebbe fallito in partenza; mentre se siamo in tanti a collaborare allora se la parrocchia va male, potrebbe iniziare ad andare bene; se poi va bene, certamente non potrà non andare meglio.
Per l’intercessione di San Donato, il Signore ci benedica tutti.
Sac. Donato Mellone
[fotoriproduzione Pignatelli Fotografi – Noha]
gen152025

E’ diventata una gran bella signora la pallavolo galatinese. A dispetto dei sessant’anni appena compiuti, sontuosamente portati, il suo appeal non è mai stato intaccato dal tempo, se è vero com’è vero, che le società sportive locali continuano a tradurre questo fascino in reclutamento e formazione dei giovani.
Un compleanno, compiuto nel novembre del 2024, che non può passare sotto silenzio. Niente festeggiamenti per uno sport secondo solo al re calcio; soltanto una rievocazione che diventa cronistoria di una specialità sportiva che ha toccato palcoscenici importanti come la serie A, sia pure in tempi molto lontani fra loro.
Ciò che non compare però negli annali di questa disciplina, stanti le diverse società che nel tempo si sono espresse in concomitanza o in alternanza nei vari campionati, è una tabella genealogica che ne attesti le radici generatrici.
E prima che la verità storiografica venga distorta, ribaltata o manipolata per essere adattata ad interessi di parte, è un obbligo fissare le origini avvalendosi di materiale probatorio (documenti federali) che blocchi qualsiasi tentativo revisionistico.
Non fosse altro per dare a Cesare quel che è di Cesare e sconfessare chi sparge ai quattro venti vanaglorie e millanterie.
Se di volley è impregnato il movimento sportivo galatinese il merito è tutto di un gruppo di militari appartenenti all’Aeronautica Militare e residenti nella vicina comunità del Villaggio Azzurro.
Anticipatori di uno sport praticato nella vasta aerea sportiva dell’aeroporto “Fortunato Cesari” dai piloti della scuola di volo e fatto proprio, ne hanno traslato didattica ed organizzazione nella loro sede residenziale.
Viene creato così, in modo artigianale, un campo di volley tracciato su un vasto spiazzo sterrato, in prosecuzione di una buca colma di sabbia e con una improbabile corsia di rincorsa destinato al salto in lungo .
Delimitato lato strada (da e per contrada Piani) da un muretto di confine e da una serie di alberi di eucalipto, era stato ricavato fuori dal perimetro dei cinque padiglioni abitativi.
E’ stata la prima palestra, naturalmente a cielo aperto, in cui si sono svolte le prime gare e gli allenamenti formativi sotto la conduzione tecnica di un triumvirato: i marescialli Bonetti, Rossano e Di Marco (mitiche le sue sigarette Giubek di tabacco orientale), docenti appassionati e di un coordinatore, il maresciallo Letterio Freni, che assunse la carica di Presidente della neonata società.
E sì, perché l’U.S.V.A., acronimo di Unione Sportiva Villaggio Azzurro, trovò la sua sede nel locale adiacente la chiesetta del villaggio, in cui il tempo libero era il perfetto mix tra passione musicale e sportiva.
Un piccolo complesso musicale capitanato dai fratelli Freni e con l’intrusione ben accolta del cantante galatinese Panariello, un duo corista Pallara e Cimmino dalle tonalità armoniche, per poi virare sulle attività sportive.
Il lancio del martello, le lezioni di scherma impartite dal maestro Cazzato, il salto in alto e in lungo, il calcio con buoni elementi finiti poi in squadre di lega dilettanti, il nuoto praticato nella piscina del Joy Club da un Salvatore Bray vero siluro d’acqua, e poi la pallavolo.
E qui comincia la storia.
Le infiltrazioni dei galatinesi nella vita sociale del Villaggio Azzurro hanno inizio con un apripista, Piero de Lorentis, la cui presenza diventa continua frequentazione.
Il rapporto amichevole con i pari età, compagni di scuola al Fermi di Lecce, prosegue con un’ospitalità accogliente e generosa che si trasforma in legame di amicizia, ancora oggi ben saldo.
Siamo nel 1963 e il solo gruppo sportivo che pratica pallavolo a Galatina, su un campetto di proprietà demaniale, è l’Unione Sportiva Villaggio Azzurro.
Giovani atleti con potenzialità in via di affinamento, statura superiore alla media, buona organizzazione di gioco e ripetute vittorie contro altre squadre che si formano in città raggiungendo il Villaggio, inducono i quattro marescialli, precursori di questa disciplina, a sviluppare un piccolo progetto.
Confrontarsi con altre realtà sportive fuori dal proprio ambito, in un campionato che abbia il crisma dell’ufficialità con l’affiliazione alla Federazione Italiana Pallavolo.
L’anno successivo, il 1964, è quello del battesimo federale. La partecipazione al campionato di Divisione Regionale, sotto la presidenza del Delegato Regionale Luigi Cecere, vede la partecipazione della neonata società Villaggio Azzurro con una squadra composta in totale maggioranza dai ragazzi del luogo.
Datati 01 novembre 1964 sono i tesseramenti federali di Mauro Pasquali (matricola fipav n°9818), Claudio Cimmino (matr. n°9817), Antonio Lecaselle (matr. 9806), Piero De Lorentis (matr. n° 9808) e via di seguito, Pippo Freni, Enzo Bray, Lino Camardo e i tanti praticanti anche di spiccate capacità (Ferraro, Romanello, Morelli ecc.) che si affrontano in ripetuti incontri.
La lungimiranza di Dino Diso, braccio operativo del neonato comitato zonale C.S.I. di Terra d’Otranto presso la Parrocchia del “Cuore Immacolato di Maria “in via Soleto, dà vita ad un raggruppamento polisportivo, sia pur poco strutturato, ma che si esprime negli ampi spazi oratoriali nelle discipline più in voga: calcio, pallavolo, basket, atletica.
L’aspetto socio-culturale di queste iniziative sportive trova la coniugazione in una forza trainante di proselitismo di chiaro e libero indirizzo cattolico che, l’allora parroco Padre Giovanni Campanella, riesce a coagulare in forti presenze giovanili alle attività di catechesi.
La numerosa partecipazione di atleti alla pratica del volley induce nel tempo i componenti dell’USVA, o almeno una buona parte di essi, a trasferirsi negli ampi spazi attrezzati sul retro della Chiesa, dando corpo al progetto che Dino Diso, attuale Presidente Vicario del CSI Terra d’Otranto, aveva messo in cantiere.
Nel tempo i campionati svolti dal CSI trovano un’organizzazione più strutturata, nel dicembre del 1967, nella neonata società Showy Boys plasmata tecnicamente nel tempo da Francesco Papadia e Fernando Panico.
Intanto la voglia di pallavolo cresce in città. Nascono altre due società la Jonica e la Mafeking, denominazione di quest’ultima in omaggio al fondatore dello scautismo, Colonnello Robert Baden-Powell, distintosi durante l’assedio in Sud Africa della cittadina Mafeking, colonia inglese, da parte dei Boeri.
Ed è proprio un’iniziativa di Corrado Panico e del suo Gruppo Scout - Galatina I - a dar vita a quella
squadra amatoriale individuando nell’atrio della chiesa di Santa Caterina, in uno spazio un po' angusto, il campo di gioco.
Poi nel 1973, il sodalizio da lui presieduto si affilia ufficialmente alla Federazione Italiana Pallavolo con la denominazione di “A.S. Vigor Galatina” - cod. società: 15.076.0029- e per un decennio gravita
tra serie C e serie B. Sfiora nel campionato 1982-1983 la promozione in serie A2 a cui partecipano i rivali della Showy Boys che al termine della stagione rinunciano alla serie A2, liberando così dal vincolo sportivo tutto il parco giocatori, molti dei quali furono tesserati dalla Vigor.
La Dirigenza in carica, pur non avendo nessun obbligo verso terzi e per una correttezza comportamentale nei confronti di quei pochi dirigenti della Showy Boys entrati a far parte del gruppo, decise di superare le divisioni cittadine aprendo ad un atto democratico: cambiò la denominazione societaria da “A.S. Vigor Galatina” a "Pallavolo Galatina", intendendo così coinvolgere sotto un’unica bandiera tutto il volley galatinese.
La FIPAV nel ratificare tale cambio di denominazione lo associò, naturalmente, al codice societario 15.076.0029, identificativo della A.S. Vigor Galatina in quanto l’altra società aveva cessato di esistere, non essendo più un soggetto sportivo federale.
E qui termina la prima parte di una storia scritta dai quattro passionari della pallavolo, i signori Bonetti, Freni, Di Marco e Rossano, in quel Villaggio Azzurro dove la memoria del loro operato non cadrà mai nell’oblio.
Piero de Lorentis
apr132019
 Arci Levèra, in collaborazione con Arci Lecce, presentano domenica 14 aprile, ore 20.30, "Cenere. Corale per le Tabacchine", spettacolo teatrale a cura di Workin' Label.
Arci Levèra, in collaborazione con Arci Lecce, presentano domenica 14 aprile, ore 20.30, "Cenere. Corale per le Tabacchine", spettacolo teatrale a cura di Workin' Label.
In scena voci e ombre di uomini e donne, tessere di un puzzle che si aggregano, una dopo l’altra, per restituire le vicende di lavoro e di vita delle operaie tabacchine del Salento.
Il cast dello spettacolo è composto da Caterina Cosmai, Angela Elia, Beppe Fusillo, Maria Grazia Gioffrè, Leila Polimeno, Luigi Pontrelli, Antonella Sabetta, Irene Scardia, Guido Scopece, Carmen Ines Tarantino. Partendo dalla ricerca e dalla raccolta di testimonianze scritte e orali, portano in scena le dure condizioni lavorative, le lotte e in particolare lo sciopero generale tenuto per 28 giorni, tra gennaio e febbraio, nel 1961 a Tiggiano, un piccolo centro del Sud Salento, contro i licenziamenti e la chiusura del Magazzino, la locale fabbrica di tabacco.
La lotta delle tabacchine di Tiggiano, che vide la mobilitazione dell’intera popolazione a sostegno delle 250 operaie, rappresentò un importante avvenimento storico, senza precedenti nella storia del paese.
A seguire proiezione del video-documentario
“TRACCE. Dialoghi sulle strade del lavoro”
realizzato con i ragazzi e le ragazze richiedenti asilo ospiti nei progetti Sprar gestiti da Arci Lecce.
Videomaker Christian Manno
Ideazione Carmen Ines Tarantino
Organizzazione Irene Scardia
L'evento di domenica è inserito nell'ambito del percorso interculturale avviato da Arci Lecce in collaborazione con Workin' Label, che ha coinvolto ragazze e ragazzi richiedenti asilo ospiti nei progetti Sprar di Campi Salentina, Caprarica, Cavallino, Castrignano dei Greci, Castrignano del Capo, Lequile, Novoli, Patù, Galatina, Sogliano, Squinzano, Surbo, Trepuzzi.
Seguiti dall'attore e pedagogo teatrale Fabrizio Saccomanno, le loro testimonianze si sono incrociate con quelle radicate nel territorio sulla lotta e l'emancipazione delle condizioni di vita e di lavoro.
Un esperimento di interazione e di dialogo interculturale e intergenerazionale, nella convinzione che l’esperienza e la storia delle persone residenti e quella dei migranti possano essere risorse importanti per la crescita della coscienza civica e solidale nelle persone di ogni età che vivono nel nostro Paese.
Appuntamento domenica 14 aprile alle 20.30 nel Circolo Arci Levèra a Noha-Galatina, via Bellini, 24.
mag222021

Ho sfidato, e più volte, la zona rossa per recarmi da Fiordilibro, la libreria della Emilia Frassanito. Voglio dire che ho azzardato l’allontanamento da Noha per quasi tre chilometri diretto alla volta di Galatina al numero 31 di corso Vittorio Emanuele, meglio conosciuta come via dell’Orologio, a dispetto delle norme che se non imponevano la clausura cenobitica ti concedevano al massimo un giretto attorno alla tua abitazione purché munito di scarpette da ginnastica. A meno, s’intende, di rigorose motivazioni da riportare su foglio ministeriale prestampato altrimenti detto autocertificazione (mica semplicemente certificazione o dichiarazione), motivi, dicevo, legati a salute, lavoro, o a casi di improcrastinabili urgenze. E io ho sempre avuto con me tutte e tre le giustificazioni: le questioni sanitarie legate alla mens sana, quelle lavorative (non puoi occuparti di economia senza l’aiuto di altri autori non economisti), e infine quelle dei bisogni primari: per alcuni i libri sono infatti aria, acqua, generi alimentari di prima necessità e non c’è Rider che possa sostituirsi al destinatario per il loro trasporto.
 |
Se poi mi avessero fermato i vigili urbani, dirimpettai della Fiordilibro, credo che mi avrebbero graziato: non perché dotato di pass acquisito sul campo dopo un articoletto a loro dedicato poco tempo fa (e credo valido per almeno un semestre), ma per il fatto che sono certo che persino per gli uomini in divisa è sempre cosa buona e giusta fare un salto nelle botteghe di parole.
Fiordilibro dunque è una delle tre benemerite librerie di Galatina “Città che legge” [si spera, ndr.], essendo le altre due Fabula e Viva (per me quest’ultima rimane sempre Viva, al di là di altri più magniloquenti posticci loghi).
Incastonata in un palazzo antico, all’ombra del campanile civico, la Fiordilibro è animata dall’Emilia, la quale, laureata in archeologia con il prof. Francesco D’Andria, dopo i suoi bravi scavi archeologici anche e soprattutto nel Salento, nel 2004 decide di lasciare in cantina trowel, piccone e pennello per dedicarsi ad altre stratigrafie, quelle che ti si sedimentano dentro pagina dopo pagina.
 |
 |
E così il ventre di codesto aedificium seicentesco si riempie di scaffali, e quindi di libri, ma poi anche di tavoli, sedie sgabelli e pedane, diventando all’occasione scriptorium e talvolta pure theatrum. Le pareti della Fiordilibro sono piene zeppe di manifesti (ne ha appesi solo alcuni, l’Emilia) a testimonianza di questo fervore, che dico, di questo fuoco che arde inesauribile, benché ultimamente sotto la cenere. Pensate, in una di codeste locandine nelle quali si parlava di tabacco e di un libro che ne racconta la storia locale c’è perfino il nome del sottoscritto (per dire quanto le mie siano braccia strappate alla cultura oppure all’agricoltura, a seconda dei punti di vista).
 |
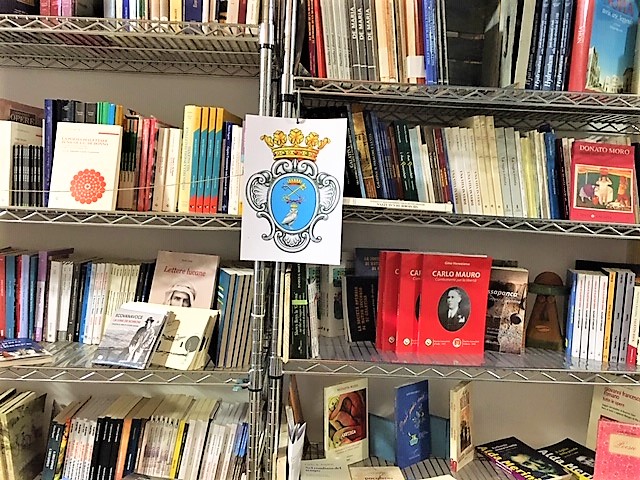 |
Quindi dialoghi con gli autori, cene letterarie, feste dei lettori, corsi di scrittura creativa (per esempio con la Luisa Ruggio nostra), musiche e parole: tutto questo certamente, ma Fiordilibro prima che una ruddhra (vivaio) di iniziative è innanzitutto una libreria, luogo sacro dove i libri ti guardano dai ripiani fino a quando non decidono di sceglierti. Qui riesci a beccare oltre a tutto il resto cose sfornate dall’editoria locale, perfino fuori catalogo (sembra esista ancora addirittura un monumentale “Noha, storia arte e leggenda” del 2006 scritto a due mani e due piedi: le mani sono quelle di Francesco D’Acquarica, i piedi, invece, i miei), le famose guide verdi di Congedo Editore, i cataloghi sulla poesia dialettale, quelli sulle torri costiere, le masserie, le ville, le campagne e gli ulivi di queste parti; e ho pescato di recente pure un “Dante e i misteri di Otranto” a proposito del settecentesimo della morte del Poeta, e poi ancora Bodini, Maria Corti, Carmelo Bene, Antonio Antonaci e Donato Moro, “e più di mille ombre [Emilia] mostrommi e nominommi a dito”.
La libraia all’occasione diventa pure una tua confidente, e a richiesta ti procura sotto banco pure i “libri proibiti” (“Non lo dico a nessuno, tranquillo”, ti rassicura), tipo quelli molto commerciali, o quelli di qualche scrittore di destra come un Marcello Veneziani (ché tu, comunista, mica puoi confessare al mondo di aver letto nemmeno per isbaglio).
Che pesi che deve portarsi dentro la povera Emilia. Ebbene sì, purtroppo la vita non è sempre tutta rose e Fiordilibro.
Antonio Mellone
set102016
 Conobbi Isa Palumbo in circostanze particolari.
Conobbi Isa Palumbo in circostanze particolari.
Eravamo nel 1983. La mia come numerose altre famiglie salentine trovava sostentamento nell’agricoltura.
Nell’ambito di questo settore la coltivazione che assorbiva pensieri, energie e ore del giorno e della notte di tutti i membri della mia stirpe, incluso il sottoscritto, era il tabacco.
Ora devo confessare che non solo non ho mai amato, ma neanche provato la pur minima simpatia per questa coltura. Ne soffrivo, anzi. Eccome.
Le mie aspirazioni non collimavano punto con l’idea dell’agricoltura quale sbocco occupazionale, non dico come impiego, ma nemmeno come ripiego. Son dovuti trascorrere diversi decenni di sudate carte perché arrivassi a comprendere finalmente l’importanza fondamentale del settore primario, e non solo dal punto di vista dell’economia.
Ma ritorniamo un attimo a quei tempi.
I miei genitori ovviamente non mi avrebbero permesso di trascorrere l’estate nel dolce far nulla: era un lusso che solo alcuni dei miei amici più fortunati di me potevano permettersi. L’ozio non era contemplato né negli schemi mentali né nel vocabolario dei miei familiari e, a dire il vero, neanche nei miei.
Bisognava dunque trovare un’alternativa all’aborrito tabacco.
Il bisogno aguzza l’ingegno anche degli sbarbatelli. Il mio mi portò in quell’amena località di mare al nord di Gallipoli che risponde al nome di Lido Conchiglie, dove venni assunto per tutta l’estate in qualità di cameriere alle dipendenze della graziosa pensione denominata appunto “Le Conchiglie”, un alberghetto di proprietà proprio della signora Luisa Palumbo, nonna di Toni Serafini, mio compagno di classe alle medie.
*
La proprietaria dell’hotel era dunque un’anziana signora, corpulenta anziché no; ma attivissima, soprattutto in cucina, e combattiva, come vidi, financo al mercato del pesce di Gallipoli dove, conosciuta da tutti, veniva rispettata anche dal più incallito e smaliziato pescivendolo all’ingrosso.
Questa donna dalla folta canizie all’inizio mi sembrò alquanto burbera. Compresi invece, in seguito alle nostre conversazioni (e ce ne furono molte), che la Isa aveva temprato il suo carattere coraggioso e agguerrito alla scuola dura delle battaglie e delle mobilitazioni, degli scioperi e delle persecuzioni degli anni cinquanta che avevano finalmente interessato anche la periferica provincia di Lecce: lotte senza le quali inesorabilmente si sarebbe rimasti ai tempi del feudalesimo dei servi della gleba.
La nostra concittadina, comunista fin nel midollo, non sopportava le prevaricazioni dei ben pasciuti borghesi a discapito dei poveri lavoratori, proprietari soltanto della forza delle loro braccia. Fu un’attivista politica soprattutto negli anni cruciali delle lotte per i diritti delle tabacchine e successivamente negli anni delle contestazioni sessantottine, a Lecce come a Roma. Sempre in prima fila (lei, casalinga) a fianco degli operai e degli studenti universitari, negli scioperi, nelle manifestazioni e nelle lotte che cambiarono il mondo sulle note di “Avanti popolo” e di “Bella ciao”, in mezzo allo sventolio delle bandiere rosse con falce e martello, simboli del lavoro nei campi e nelle fabbriche: vessilli che garrivano con fierezza ad ogni vento, soprattutto se contrario.
Una volta le chiesi spiegazioni circa una sua cicatrice sulla fronte. Mi disse che si trattava del ricordo di un tumulto avvenuto nella capitale allorché nel ’68 ne racimolò una manganellata da parte di un poliziotto, il cui segno (una decina di punti di sutura) rimase quale marchio indelebile della sua indole che pare volesse dire agli interlocutori: “mi spezzo ma non mi piego”.
“Accorgiamoci dell’ingiustizia. – soleva dire - Se ci mettiamo insieme, se ci difendiamo, allora i padroni non possono far nulla. I diritti si ottengono con la lotta. Se non difendi tu il tuo pane, nessuno ti tutela”.
 Ed ancora: “Noi cercavamo di parlare alle tabacchine, in riunioni di caseggiato, nelle fabbriche, nelle borgate, nei locali più svariati per renderle edotte della loro condizione e dei loro tabù. Ma non era facile. Chi per paura, chi per quieto vivere, chi per ignoranza, pur condividendo apparentemente quello che dicevamo, difficilmente si esponeva per rivendicare quello che gli spettava” [Queste parole sono estrapolate dall’intervista alla Isa tratta dal documentario di Luigi del Prete intitolato “Le tabacchine. Salento 1944 – 1954”, edizioni Easy Mañana, 2003].
Ed ancora: “Noi cercavamo di parlare alle tabacchine, in riunioni di caseggiato, nelle fabbriche, nelle borgate, nei locali più svariati per renderle edotte della loro condizione e dei loro tabù. Ma non era facile. Chi per paura, chi per quieto vivere, chi per ignoranza, pur condividendo apparentemente quello che dicevamo, difficilmente si esponeva per rivendicare quello che gli spettava” [Queste parole sono estrapolate dall’intervista alla Isa tratta dal documentario di Luigi del Prete intitolato “Le tabacchine. Salento 1944 – 1954”, edizioni Easy Mañana, 2003].
La pasionaria di Noha non spingeva alla ribellione soltanto per la povertà, la paga misera, la fame, lo sfruttamento, la corruzione, il riconoscimento degli assegni di maternità, ma soprattutto per il peso insopportabile della dignità oltraggiata dal capitalismo, che allora aveva le fattezze del ricco proprietario terriero o dell’opulento concessionario del tabacco.
Divenne così un’agguerrita sindacalista, una capopopolo, sempre presente nelle piazze e sui palchi dei comizi, pronta a prendere la parola, che scandiva con risolutezza e con un italiano impeccabile.
La Isa non era affetta da timori reverenziali, nemmeno nei confronti del prefetto di Lecce, il terribile Grimaldi, che aveva tentato di sminuire il valore della sua rappresentanza.
Sentite direttamente dalle sue parole il racconto di quanto avvenne il 24 settembre 1944, giorno di grande sciopero a Lecce: “Quando incominciò la lotta per ottenere il sussidio straordinario di disoccupazione iniziammo a mobilitarle tutte. Mentre discutevamo con il Prefetto, questi se ne uscì dicendo con supponenza: ‘Ma sì, in fin dei conti rappresentate sì e no cinquanta tabacchine in tutta la provincia’. Io gli risposi: ‘Senta eccellenza, domani mattina le farò vedere quante tabacchine rappresento’.
La notte, a piedi, in bicicletta, con la macchina e con ogni mezzo, avvisammo tutta la provincia: ‘DOMANI MATTINA TABACCHINE E CONTADINI TUTTI A LECCE!!!’
All’indomani mi presentai dal Grimaldi perché ero di commissione e gli dissi: ‘Venga: le faccio vedere le tabacchine che rappresento!’
Affacciatosi alla finestra il prefetto non credeva ai propri occhi: circa 40.000 tra contadini, e soprattutto operaie e lavoratrici del tabacco, gremivano le strade e le piazze del centro di Lecce”.
*
La fissità arcaica dei rapporti sociali fondati sull’abuso della vita non è poi così lontana dai nostri tempi. I ragazzi di colore che raccolgono angurie e angherie sono qui, a due passi da noi, nel neritino, non nel Polo Nord. Ma ad esser vessati non sono soltanto gli extracomunitari (che ci ostiniamo a chiamare “clandestini” e non invece profughi in fuga dalle nostre bombe), ma anche i nostri congiunti: gli schiavi moderni ce li abbiamo in casa, magari con tanto di laurea in tasca. Sono le giovani vittime del Jobs Act, i lavoratori flessibili, quelli con i voucher, i full-time con contratti part-time, gli esuberi, i licenziati, i disoccupati in aumento, e quelli che hanno smesso di cercare un lavoro. Sono gli sfruttati in nome della “competitività”.
E senza una presa di coscienza, cioè una nuova ‘coscienza di classe’, prima o poi saremo tutti vittime di questo capitalismo di rapina che ammazza diritti, ragione e ambiente.
*
Così la Isa concludeva la sua intervista a Luigi del Prete: “Finché ci sarà il ricco che può comprare ed il povero che si fa comprare non ci sarà giustizia. E quei pochi che vogliono uscire da questa oppressione ci rimettono la pelle! […] L’emancipazione della donna non sta nelle calze di nailon, nel cappotto di pelliccia, o nella macchina. L’emancipazione non è questa. La vera emancipazione è chiedersi: chi sono io, che cosa posso dare alla vita, che cosa posso ricevere dalla vita”.
*
La Isa ora riposa in pace nella cappella di famiglia nel cimitero di Noha.
Intorno alla sua tomba in primavera ho visto crescere spontanei gruppi di papaveri rossi.
Antonio Mellone
dic222009
Eccovi di seguito l'n-esimo articolo di Antonio Mellone apparso sulla rivista bimestrale "Il filo di Aracne" nel numero di dicembre 2009. Si tratta della recensione del recente libro "Infanzia Salentina" del nostro amico prof. Gianluca Virgilio
Infanzia Salentina, un esorcismo generazionale

Avevo poco più (o poco meno) di cinque anni.
Quella mattina verso le otto, mentre ero pronto per andare alla scuola materna che frequentavo, non ricordo come (forse mia madre mi ci aveva portato mezzo addormentato all’alba), mi trovavo nella casa della nonna, ad un fischio dalla mia, sempre a Noha.
Quella mattina mia madre prendendomi in disparte mi disse: “Oggi la nonna è andata in cielo”.
Io corsi subito sulla terrazza di quella casa - allora una delle poche abitazioni nohane al primo piano, essendo le altre quasi tutte al piano terra - alzai lo sguardo per scrutare il cielo, cercando di avvistare mia nonna.
Era primavera, il cielo era terso, azzurrissimo. Ma mia nonna non la vidi punto.
Rientrai in casa un po’ confuso. Ci pensò mia madre stessa - che dall’espressione sembrava volermi dire: stupidino! - ad indicarmi in anteprima, cioè prima che iniziassero le visite di parenti e amici per le condoglianze, la mamma di mio padre composta nella sua bara.
Sembrava dormisse, ed io non avevo realizzato ancora che mia nonna (quella brava donna che, prima di chiederti se ne volevi, aveva già preparato la fetta di panetto con pomodoro olio e sale) non c’era più. Non avevo cioè compreso che mia nonna era morta. Tanto che alla scuola materna (mi ci mandò comunque mia madre in quella mattinata di trambusto) le suore chiesero a me ed a mio cugino se la nonna fosse ritornata dall’ospedale.
Mio cugino era all’oscuro delle ultime novità. Infatti mia zia Giovanna, sua madre, non l’aveva reso edotto di “tutto”. E rispose alle suore che nonna Maria Scala (proprio questo era il suo nome, mentre il cognome era Tundo) era ancora in ospedale; io invece che ormai sapevo “tutto” dissi subito che era ritornata, e che l’avevo addirittura vista in carne ed ossa in mattinata. Ma non precisai che l’avevo vista in una bara, né che, come m’era stato riferito, se ne fosse volata in cielo. Non avevo ancora preso coscienza del concetto di bara e soprattutto di un accadimento che, come in seguito capii, era (ed è) cosa molto frequente: la dipartita di una persona.
Questa è una delle mille storie che mi sono frullate per la testa mentre leggevo il bellissimo affresco di una generazione: “Infanzia Salentina” di Gianluca Virgilio (Edit Santoro, Galatina, 2009, 172 pagg.).
Sì, perché leggere questo volumetto significa pensare a tanti accadimenti, tante coincidenze, tante storie affini od opposte, tanti ricordi.
Come ancora ad esempio il tempo delle vacanze, che Gianluca, figlio di professore, trascorreva a Santa Maria di Leuca, mentre io, figlio di contadino, trascorrevo (lavorando!) in campagna, nel mare del tabacco le cui foglie ed i cui taraletti si aggrappavano alla mia infanzia per non staccarsene più. O come il fatto delle giostre che nel corso della festa di San Michele venivano montate fin nei pressi del portone di casa mia (l’ingresso più utilizzato coincideva e coincide anche oggi con il garage), tanto da consentire appena il nostro accesso pedonale, ma non quello della nostra 500 Bianchina, che rimaneva fuori allo scoperto per i tre giorni della festa. Ma nonostante i borbottii dei miei, io ne ero contento, perché mi trovavo nel centro del paese dei balocchi, ed anche perché i giostrai a volte mi facevano omaggio di qualche gettone per le auto-scontro, forse quale forma di risarcimento per il loro disturbo (che per me non lo era affatto).
O come l’amicizia con la famiglia Papadia: quei Papadia che vantano nel loro albero genealogico messer Baldassarre Papadia, autore delle Memorie storiche della città di Galatina nella Japigia, ma anche la (contemporanea) gentile signora Maria Cristina, custode gelosa della stupenda biblioteca paterna, che ho più volte visitato; questa amica che insieme al consorte Paolo, non più tardi di qualche settimana fa, m’ha invitato nella sua bella e storica dimora (adiacente alla Basilica di Santa Caterina) proprio per farmi esaminare le diverse raccolte di giornali d’epoca, di quaderni, di “Domenica del Corriere”, di libri non ancora catalogati nella suddetta biblioteca. Rovistando ben bene tra quelle carte sono certo che si troverebbe l’emeroteca delle riviste di parole crociate, quelle sulle quali il papà di Cristina, il signor Raffaele, capo dell’ufficio imposte di Gallipoli, si esercitava nel tempo libero delle famose vacanze leucane…
Il libro di Gianluca Virgilio, come gli altri suoi libri di cui ho avuto modo di parlare altrove, ricorda la svelta forma tipografica dei tascabili dell’editore Sellerio, l’editore dei famosi libri di Andrea Camilleri e Gianrico Carofiglio. Ma qui siamo di fronte ad una casa editrice galatinese e non di Palermo, la Edit Santoro; e poi siamo in presenza di un caro figlio di Galatina, dal quale ormai ci aspettiamo anzi pretendiamo un romanzo!
“Infanzia Salentina” è un libro di storie e sentimenti, di tramonti giallo-oro e di schiamazzi di bambini dalle ginocchia sbucciate, di mamme e di zii, di scuola e di febbre per lo sviluppo, di primi turbamenti amorosi e di amicizie che durano una vita, di bagni domenicali nella vasca verde (la mia, pur sempre di plastica, era azzurra) e di giochi in mezzo alla strada: un libro non soltanto di memoria individuale, ma anche, se vogliamo, di esorcismo generazionale. Un libro che ti fa capire che il bisogno di scrivere ed anche di leggere è un tutt’uno con la vita. E chi legge “Infanzia Salentina” non legge Gianluca Virgilio, legge se stesso.
Antonio Mellone
ago042018
 Il vocabolario d’italiano della mia famiglia non contemplava il lemma “vacanza”: che invece credeva fosse (e crede tuttora sia) arabo.
Il vocabolario d’italiano della mia famiglia non contemplava il lemma “vacanza”: che invece credeva fosse (e crede tuttora sia) arabo.
Sicché, come detto altrove, nell’infausto mese di giugno da noi iniziava la Raccolta Del tabacco e sul tema non erano previsti margini per chissà quali speculazioni filosofiche da parte di uno sbarbatello come il sottoscritto che prima di diventare un No-Tap era giustamente un No-Tab (Tab = tabacco).
Si partiva senza indugio con il frunzone, cioè le prime foglie in basso, quelle che toccavano terra, le peggiori, le più infide. Io raccoglievo ginocchioni queste benedette foglie, strisciando nella polvere della dura gleba manco fossi un devoto pellegrino genuflesso in uno dei santuari del Prodotto Interno Lourdes (Pil).
Avevo le ginocchiere a quei pantaloni inguardabili di due taglie più grandi. Nel frattempo ogni foglia strappata alla pianta era un’imprecazione dentro di me e una fervida preghiera a Zeus, dio del fulmine, affinché benigno scagliasse su quelle piantagioni la più portentosa delle sue sajette. Credo di essere stato uno dei precursori, se non proprio l’inventore, della Giornata Mondiale Senza il tabacco che tanto successo riscuote oggi in ogni angolo della terra.
 La raccolta avveniva la mattina presto prima del canto del gallo. Per dirvi il livello di disperazione ero arrivato a invidiare perfino quello stupido pollastro che, per quanto stupido, aveva comunque il privilegio di svegliarsi dopo di me. E voi non potete nemmeno immaginare il groviglio dei miei pensieri all’indirizzo dei suoi avi defunti.
La raccolta avveniva la mattina presto prima del canto del gallo. Per dirvi il livello di disperazione ero arrivato a invidiare perfino quello stupido pollastro che, per quanto stupido, aveva comunque il privilegio di svegliarsi dopo di me. E voi non potete nemmeno immaginare il groviglio dei miei pensieri all’indirizzo dei suoi avi defunti.
Si lavorava dunque al lume di luna e stelle: e io mi sentivo alternativamente un po’ Giacomo Leopardi pervaso dal pessimismo cosmico, a tratti un licantropo (il famoso lupo mannaro americano a Noha), e talvolta un vampiro ormai terrorizzato dalla luce del sole.
*
Il tabacco si cuciva con l’acudeddhra, un ago lungo trenta o quaranta centimetri. Quest’aculeo d’acciaio, venduto anzi spacciato dagli zingari al mercato del giovedì di Galatina, presentava una cruna dove si infilava lo spago di circa un metro di lunghezza. Io da quella cruna m’aspettavo di veder passare tranquillamente un cammello, piuttosto che il ricco di turno - che si stava viepiù arricchendo anche grazie al mio indefesso lavoro - entrasse nel regno dei cieli.
 Quando si riempiva la filza si staccava dall’ago e, doppiandola, la si parcheggiava di fianco insieme a tutte le altre. C’era anche una sorta di gara fra poveri cristi su chi ne sfornasse di più. Anni dopo all’università appresi che questa abiezione si chiama produttività, ovvero asserto di Kunta Kinte (quest’ultimo enunciato è copyright del sottoscritto).
Quando si riempiva la filza si staccava dall’ago e, doppiandola, la si parcheggiava di fianco insieme a tutte le altre. C’era anche una sorta di gara fra poveri cristi su chi ne sfornasse di più. Anni dopo all’università appresi che questa abiezione si chiama produttività, ovvero asserto di Kunta Kinte (quest’ultimo enunciato è copyright del sottoscritto).
Le mani era praticamente impossibile proteggerle con i guanti di plastica o con preservativi di altro materiale, tanto che in breve si riempivano di quella sorta di grasso nero appiccicoso e insopportabile, altrimenti detto siu. In quei frangenti, intrattabile com’ero, era pressoché impossibile avvicinarmi, pena la topica imprecazione icastica idiomatico-liberatoria indirizzata urbi et orbi che suona: cu butti lu siu.
*
Dopo l’infilatura o la cucitura bisognava appendere le corde al telaio (taralettu) per l’essiccatura.
Ebbene. Quando il tempo si annuvolava o quando iniziava a piovere (chissà come mai i temporali estivi capitavano proprio quando avevi da poco posato il capo sul cuscino per la sacrosanta pennichella pomeridiana) eri costretto ad alzarti dalla branda per correr fuori all’impazzata a ricoprire i telai/taraletti con la Manta Di Plastica. Chi se ne fregava se t’inzuppavi con l’acqua dei gavettoni scagliati dagli angeli del cielo in vena di scherzi da caserma: l’importante era non farla prendere al tabacco che poteva sciuparsi o assumere un colore sgradito al monopsonista acquirente dotato di cravatta in senso letterario e in senso letterale. Per la cronaca nessun tabacco, nemmeno il più curato nei dettagli, fu mai pagato adeguatamente e soprattutto per pronta cassa. E tu, insieme a molti altri, eri costretto ad ascoltare sotto le volte del magazzino di consegna la solita salmodiante voce del padrone che faceva: àggili bbire [i.e. aspetta e spera].
*
Decenni dopo arrivò Marchionne (parce sepulto), amministratore delegato della fabbrica dei consensi, incensato dal clero mediatico-giornalistico dell’ordine del neoliberismo, e applaudito dal gregge di fedeli precarizzati e senza coscienza.
Ancora fumo. Di quello buono.
Antonio Mellone
nov122023
A Noha non fai in tempo a stupirti per un murales dal pennel fuggito che all’indomani te ne ritrovi un altro, sulla medesima parete, a mo’ di rattoppo a colori un tantino più kitsch del precedente. Assodato che il materiale usato è tutto men che inchiostro simpatico a scomparsa, assalito da vecchi e nuovi dubbi esistenziali ti chiedi: ma la fanno apposta a tirarti dietro i secchi di vernice per due soldi quando l’inflazione dell’Area Euro è ancora galoppante?
Per chi non fosse addentro al mistero di The Wall provo a riassumere i termini della Quistione. Un bel giorno di fine estate i nohani si ritrovano il muro dell’ufficio anagrafe di via Calvario pitturato di un azzurro pastello tendente all’acquamarina quando è scirocco squaiato. Per la verità all’inizio non ci avevano fatto tanto caso, son fatti così e molti di loro si fanno scivolare addosso questo e ben altro; poi qualcuno ha iniziato a blaterare, a ragion veduta, di Bonus Sfacciati, mentre qualche altro ha ipotizzato l’apertura in quei locali di una succursale del mercato ittico gallipolino (ebbene sì, ultimamente la realtà sembra librarsi sulle ali di un ippogrifo).
 Insomma, pennellata dopo spennellata, appaiono in tutto il loro splendore una ragnatela, un’enorme taranta pelosa ca mancu li cani, e soprattutto l’immagine di un San Paolo fuori le mura, anzi due San Paolo (la famosa bilocazione, prima e dopo la conversione sulla via di Damasco), con tanto di aureola, spada, mantello, barba, ma questa volta senza nemmeno gli occhi (per piangere). Dopo le prime paralisi facciali con bocca spalancata e sopracciglio immobile degli astanti, le consequenziali considerazioni circa la discutibile reputazione delle nonne dei rispettivi protagonisti dell’affaire, le interrogazioni dell’opposizione e la prima e ultima reazione della virginea amministrazione cittadina che aveva tutta l’aria di un: “E mo’ che cazzo gli diciamo a questi?”, i Macchiaioli de nohantri, tronfi manco avessero dipinto il Giudizio Universale alla Sistina, dopo aver cancellato il tutto fischiettando come niente fosse, tirano fuori dal cilindro di tinta una falce senza martello, un carretto bonsai volante, un campo di cereali del foggiano (con il Gargano incorporato), un rettangolo oblungo che vorrebbe somigliare al puteale di un pozzo, una spigolatrice da fare invidia a quelle del Millet, e finalmente alcune piante di tabacco del tempo che fu, vegetali del tutto sconosciuti alle Generazioni Alpha e Z, e credo pure ai Millennials, i cui esponenti, al pari del noto gruppuscolo di scienziati à la page, confidando nelle sempreverdi varietà “resistenti alla Xylella”, avranno esclamato a gran voce e alquanto stupefatti: “Evviva Maria!”.
Insomma, pennellata dopo spennellata, appaiono in tutto il loro splendore una ragnatela, un’enorme taranta pelosa ca mancu li cani, e soprattutto l’immagine di un San Paolo fuori le mura, anzi due San Paolo (la famosa bilocazione, prima e dopo la conversione sulla via di Damasco), con tanto di aureola, spada, mantello, barba, ma questa volta senza nemmeno gli occhi (per piangere). Dopo le prime paralisi facciali con bocca spalancata e sopracciglio immobile degli astanti, le consequenziali considerazioni circa la discutibile reputazione delle nonne dei rispettivi protagonisti dell’affaire, le interrogazioni dell’opposizione e la prima e ultima reazione della virginea amministrazione cittadina che aveva tutta l’aria di un: “E mo’ che cazzo gli diciamo a questi?”, i Macchiaioli de nohantri, tronfi manco avessero dipinto il Giudizio Universale alla Sistina, dopo aver cancellato il tutto fischiettando come niente fosse, tirano fuori dal cilindro di tinta una falce senza martello, un carretto bonsai volante, un campo di cereali del foggiano (con il Gargano incorporato), un rettangolo oblungo che vorrebbe somigliare al puteale di un pozzo, una spigolatrice da fare invidia a quelle del Millet, e finalmente alcune piante di tabacco del tempo che fu, vegetali del tutto sconosciuti alle Generazioni Alpha e Z, e credo pure ai Millennials, i cui esponenti, al pari del noto gruppuscolo di scienziati à la page, confidando nelle sempreverdi varietà “resistenti alla Xylella”, avranno esclamato a gran voce e alquanto stupefatti: “Evviva Maria!”.
Nell’attesa dell’aggiornamento del nostro Murales a Ore con un nuovo affresco però a caldo da parte del Bansky di turno, e del connesso Vernissage tutto circenses senza panem di cui l’attuale Giunta postdemocratica sembra essere l’incontrastata paladina, per non farci mancare nulla, gli ormai popolarissimi collezionisti di fiaschi (recipienti fatti apposta per i Negramaro), piuttosto che perder tempo, che so io, nella convocazione di un consiglio comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria a Julian Assange (perché mai spendere una parola a favore di chi osi documentare i crimini di guerra del democratico Occidente), dichiarano la loro formidabile controffensiva a suon di esposti in Procura a prezzi di saldo contro chiunque ardisca mettere in discussione una delle quattro P del loro Marketing Mix (vale a dire Prezzo, Promozione, Pubblicità e Puttanate).
 Scomparsa dalla circolazione la quinta P (quella della Politica), nell’attesa di conoscere chi sarà il fortunato vincitore del Premio Querelato Autunno/Inverno 2023 da scolpire a perenne monito nel Famedio Galatinese [nessun accesso agli atti per scoprirne il nome: basterà un comunicato del locale Club Unesco, ndr.], il sindaco manager/imprenditore, e a tempo perso brillante istrione, continuerà a deliziarci sopra o sotto ogni genere di palcoscenico delle sue genialate, fatte di patti d’acciaio, o forse di cemento tra Galatina e Assisi (leggermente all’insaputa degli assisiati); di innocenti inchini (vassallaggio tuonerebbero i malpensanti) alle tanto bio-green-eco-inclusive ciminiere di pertinenza del filantropo per antonomasia nonché mecenate e ovviamente Cavaliere del Lavoro (a cavallo di un elicottero), senza dubbio in nome della povertà francescana; di “inizio di un percorso” più volte ribadito ma non si capisce esattamente per dove; di piatti di lenticchie chiamati ristori offerti da aziende pronte a fare Terna al lotto in queste lande promosse al rango di colonie; di video motivazionali per i Pollowers in visibilio, e quindi di tanta cultura in kermesse piene zeppe di “forte attrattiva”, di “appeal assolutamente sovranazionale”, e di “bollini di qualità” in “connubio perfetto” con la meglio “Galatina mia”.
Scomparsa dalla circolazione la quinta P (quella della Politica), nell’attesa di conoscere chi sarà il fortunato vincitore del Premio Querelato Autunno/Inverno 2023 da scolpire a perenne monito nel Famedio Galatinese [nessun accesso agli atti per scoprirne il nome: basterà un comunicato del locale Club Unesco, ndr.], il sindaco manager/imprenditore, e a tempo perso brillante istrione, continuerà a deliziarci sopra o sotto ogni genere di palcoscenico delle sue genialate, fatte di patti d’acciaio, o forse di cemento tra Galatina e Assisi (leggermente all’insaputa degli assisiati); di innocenti inchini (vassallaggio tuonerebbero i malpensanti) alle tanto bio-green-eco-inclusive ciminiere di pertinenza del filantropo per antonomasia nonché mecenate e ovviamente Cavaliere del Lavoro (a cavallo di un elicottero), senza dubbio in nome della povertà francescana; di “inizio di un percorso” più volte ribadito ma non si capisce esattamente per dove; di piatti di lenticchie chiamati ristori offerti da aziende pronte a fare Terna al lotto in queste lande promosse al rango di colonie; di video motivazionali per i Pollowers in visibilio, e quindi di tanta cultura in kermesse piene zeppe di “forte attrattiva”, di “appeal assolutamente sovranazionale”, e di “bollini di qualità” in “connubio perfetto” con la meglio “Galatina mia”.
Nah: da Galatina come eravamo, a Galatina come ci siamo ridotti.
Antonio Mellone
feb212015
 La situazione del complesso del disseccamento rapido degli olivi sta diventando veramente problematica. Sono state pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione, le “Misure fitosanitarie obbligatorie per il contenimento delle infezioni di Xylella fastidiosa” da attuare nella zona infetta, cioè in tutto il Salento.
La situazione del complesso del disseccamento rapido degli olivi sta diventando veramente problematica. Sono state pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione, le “Misure fitosanitarie obbligatorie per il contenimento delle infezioni di Xylella fastidiosa” da attuare nella zona infetta, cioè in tutto il Salento.
L’obiettivo è, visto che non si riesce a curare gli alberi malati, agire sull’insetto vettore (Cicalina), tramite un uso massiccio di fitofarmaci mai visto prima. Se si immagina di voler debellare un insetto quasi più piccolo di una mosca in tutto il Salento, si fa presto a capire lo scenario che ci si prospetta.
Il testo dice chiaramente che è fatto obbligo ai proprietari o conduttori dei terreni ricadenti nell’area infetta di eseguire le misure obbligatorie, distribuendo insetticidi su tutta la superficie dei campi e conservare le ricevute dell’acquisto di fitofarmaci, attrezzi, ecc, per almeno 3 anni, come prova dell’avvenuto trattamento. È fatto obbligo di utilizzare gli insetticidi indicati nel documento sia sugli olivi, che sui campi, sull’erba, sull’incolto, sui muretti a secco, addirittura sulla macchia mediterranea. Se qualcuno dovesse rifiutarsi di compiere tale atto, i funzionari regionali sono legittimati ad accedere ai campi e fare quello che non è stato fatto. Tutto questo avrà ricadute tragiche su l’intero ecosistema, la falda, il terreno, l’aria, gli insetti impollinatori, e dunque la salute di tutti. Le api morirebbero, questo è chiaro, con tutte le ricadute sulla fertilità delle piante e l’impollinazione delle stesse. Sarà una strage, una tabula rasa.
Ci sono molte lacune e dubbi sia sulla reale efficacia di un metodo così drastico e dannoso, sia sull’avvenuta ricerca di reali alternative di cura e prevenzione. Inoltre sarà vietato il reimpianto di altri olivi per almeno 3 anni e, allo scadere di questi, non potranno essere reimpiantate le nostre varietà tradizionali (Cellina e Ogliarola) ma “varietà resistenti”. A chi giova tutto questo?
Il Salento è saturo di nocività diffuse, chiunque abbia occhi per vedere può rendersi conto dello stato in cui versano le campagne, in special modo gli oliveti, ridotti a campi da tennis per l’uso massiccio di fitofarmaci. L’olio nostrano (non biologico) è pregno di residui chimici, tanto che non viene nemmeno accettato dai mercati esteri, molto più rigidi in fatto di salute alimentare. Un’olivicoltura dunque non solo nociva ma anche incapace di creare benefici economici.
Decine di documenti del secolo scorso, testimoniano un riversamento incredibile di sostanze chimiche nel Salento utilizzate principalmente nella coltura del tabacco. È dunque comprovato che da numerosi decenni il nostro terreno, le nostre falde e tutti gli esseri viventi vengono sistematicamente contaminati e minati nel loro benessere biologico. La straordinaria incidenza di tumori in questo territorio non è forse il risultato di questo avvelenamento di massa che perdura fino ai giorni nostri?
È ora di parlar chiaro. Chi utilizza queste sostanze nell’agricoltura, sul nostro cibo, sta compiendo un danno enorme, un crimine che ricade su tutti.
Le esternalità negative di queste azioni sono pagate dalla collettività e da tutte le specie a carissimo prezzo. Per quale motivo dobbiamo subire questa vera e propria violenza, favorita anche dalla disinformazione, dalla cattiva informazione e dall’ignoranza?
Questo non è un problema del settore agricolo, è un problema collettivo.
Pretendiamo che sia fatto tutto il possibile affinché vengano individuati metodi meno dannosi di contrasto alla patologia in questione e pretendiamo che vengano messi al bando tutti i veleni utilizzati in agricoltura.
Basta nocività.
Francesca Casaluci
(di Guida Salento Kilometri Zero)
apr192006

Il libro è di imminente pubblicazione ed è indirizzato e dedicato al ricercatore, allo storiografo, allo studioso, all’archeologo, e al curioso di fatti e di pensieri di ieri e di oggi; a chi, pur costretto a vivere la sua vita altrove (dedito all’incremento del PIL, prodotto-interno-lordo, delle contrade che non sono quelle in cui nacque), non imbastardisce volutamente la sua cadenza, per non dimostrare di essere cittadino del sole, magari con le “s” sibilate in maniera goffa, sicché non sai più se si tratti di cadenza del Nord, del Sud o di nessun luogo; a chi ritornando “al paese” non si sente come un pesce fuor d’acqua; a chi non snobba le sue origini, ma ne va fiero; a chi, per studio o per lavoro, ha dovuto lasciare la propria terra natìa per portare altrove le proprie braccia, il proprio cervello e i propri sogni; a chi vivendo lungi da Noha, pur avendo a volte il viso pallido e contratto dallo stress, si rilassa pensando al ritorno nella sua terra, ai suoi orizzonti, al suo mare, alla sua aria pura, al bianco delle case su cui riverbera la luce meridiana che quasi abbacina gli occhi; a chi è attaccato alle proprie radici; a chi prova nostalgia fin nelle fibre più intime; a chi ama la pennichella pomeridiana; a chi sa apprezzare il profumo della campagna che fu degli avi, che coltivarono gli ulivi, attorcigliatisi nel corso dei secoli, ed il tabacco, che assorbiva il lavoro di tutta la famiglia intenta ad infilare le foglie nei canapi dei taraletti; a chi ama il mare in tutte le stagioni e non soltanto d’Agosto; a chi vive interiormente la passione di quella sorta di cordone ombelicale che lega ai propri parenti, ai nonni, agli zii, ai fratelli, ai padri, alle madri; a chi è legato alla piazza del proprio paese dove trova sempre un amico, anche senza il bisogno di fissare un appuntamento; a chi crede che un libro faccia viaggiare più di un aereo, faccia sentire suoni, gustare sapori e annusare odori; a chi pensa che la micro-storia del proprio paese, per quanto piccolo questo possa essere, contribuisca comunque a fare la macro-storia o storia generale; a chi vive a Noha, o a chi, pur non vivendoci, vi è legato, in un modo o nell’altro, da un sentimento o da un ricordo.
Per visualizzare la copertina completa del libro clicca qui.
ago162015
 All’inizio, leggendo di sfuggita il manifesto (quando sei in macchina riesci a scorrere o a decifrare solo i caratteri cubitali senza alcuna possibilità di soffermarti sui particolari), non avevo capito che la defunta Maria Pietrina Pepe era la Mariannina. Poi, una volta a casa, me lo ha riferito mia madre che non c’era più la nostra dirimpettaia di campagna, la mamma di Marcello, della Rosanna, della Maria Luce, della Lidia e della Tina Pepe (quando nomini la Tina non puoi ometterne il cognome). E pensare che avevo chiesto a mia madre della Mariannina solo qualche giorno prima, e m’ero tranquillizzato avendo saputo che anche quest’anno, nonostante gli acciacchi (ma la vecchiaia è già di per sé una malattia) si era “ritirata in campagna”.
All’inizio, leggendo di sfuggita il manifesto (quando sei in macchina riesci a scorrere o a decifrare solo i caratteri cubitali senza alcuna possibilità di soffermarti sui particolari), non avevo capito che la defunta Maria Pietrina Pepe era la Mariannina. Poi, una volta a casa, me lo ha riferito mia madre che non c’era più la nostra dirimpettaia di campagna, la mamma di Marcello, della Rosanna, della Maria Luce, della Lidia e della Tina Pepe (quando nomini la Tina non puoi ometterne il cognome). E pensare che avevo chiesto a mia madre della Mariannina solo qualche giorno prima, e m’ero tranquillizzato avendo saputo che anche quest’anno, nonostante gli acciacchi (ma la vecchiaia è già di per sé una malattia) si era “ritirata in campagna”.
Chissà perché il ricordo delle persone anziane ci riporta sovente al tempo della nostra infanzia, il periodo della nostra vita che si conficca come un amo nella carne per non staccarsene più. E il ricordo di Mariannina, donna energica, grande lavoratrice, il rosario sempre a portata di mano, come lo scapolare del Cuore di Gesù, classe di ferro 1922, dunque 93 primavere sulle spalle, capelli bianchi e ciglia nere (caratteristica dei Pepe), non sfugge a questa regola aurea.
Io ero di casa dalla Mariannina, ci andavo di tanto in tanto accompagnando mia madre. Le nostre campagne sarebbero confinanti, adiacenti, unite, se non fossero divise dalla strada statale Noha – Collepasso. E un tempo tra i campi non c’erano, come purtroppo oggi è, quelle barriere architettoniche rappresentate da cancelli, siepi, muri perimetrali alti due metri, ma solo un ostacolo ove possibile ancora più insormontabile, vale a dire la mancanza di tempo per via del lavoro che assorbiva molte ore del giorno (e della notte) di tutti i componenti delle famiglie, dal primo fino all’ultimo. Sì, con la produzione del tabacco il concetto di villeggiatura per i furesi assumeva tutto un altro significato (tanto che il sottoscritto preferiva mille volte le collezioni scolastiche autunno-inverno che le infilate primavera-estate).
Sta di fatto che non poche volte, sovente di pomeriggio, quando possibile, e quando c’era qualcosa da scambiarsi (come i pomodori, i peperoni, le pupuneddhre, il basilico, qualche puccia con le olive, o anche il bidone grande per le bottiglie di salsa da cuocere a bagnomaria - un tempo l’economia del dono era parte del DNA della cultura contadina) o andavamo noi oppure venivano loro da noi: la Mariannina e suo marito Pascalinu (pace anche all’anima sua), uomo buono, di poche parole (come, del resto, anche mio padre: manco li avessero fatti con lo stampino).
Io ricordo benissimo che la Mariannina, quando ero da lei, non mi faceva mai mancare un bel bicchiere di aranciata fresca, qualche biscotto, e i fichi appena raccolti. Dolci ricordi.
Quando ho appreso della sua morte, come un flash, mi son venute in mente anche le processioni del Corpus Domini, quelle solenni con il pallio, il baldacchino color porpora enorme e maestoso, le cui sei aste lignee erano rette da altrettanti robusti giovani, mentre il turibolo per l’incenso toccava a quell’imberbe ragazzino vestito da chierichetto che risponde al nome dello scrivente.
Ebbene, in via Catania non c’erano gli altarini (che invece erano allestiti altrove), ma il Corpo di Cristo non mancava degli onori, delle luci e dei fiori (e soprattutto delle preghiere) da parte dei devoti. Quando passava la processione solenne da quella strada (la casa della Mariannina si affaccia su due strade, via Fabio Filzi, la porta de nanti e, dunque, via Catania), una pioggia di petali di rosa e di altri fiori ricadeva, come fiocca la neve, lenta e silenziosa, sul percorso processionale, sui devoti e sul baldacchino: era la Mariannina a lanciarli, discreta e orante, dalla terrazza di casa sua. Lo ricordo come fosse ieri.
Ora, Mariannina, tutti quei petali di rose variopinte sono gli angeli lanciarteli al tuo passaggio, mentre varchi di corsa e con gioia, senza più il bisogno di una sedia a rotelle, la soglia del tuo meritato Paradiso.
Antonio Mellone
Condoglianze ai figli, ai parenti tutti, agli amici, alla comunità nohana da parte della redazione di Noha.it
ott042023

Dopo settimane di polemiche sulla realizzazione del murales di Noha, è arrivato il momento di fissare un punto di verità e di raccontare, in maniera chiara, l’intera vicenda.
Lo facciamo oggi dopo il consiglio comunale e dopo aver risposto all’interrogazione della minoranza.
Iniziamo con il dire che il progetto all’interno del quale è inserita la realizzazione del murales è stato presentato dalla precedente amministrazione all’interno dell’INIZIATIVA STHAR LAB “Laboratori di fruizione per la promozione e la valorizzazione della street art, dei teatri storici e degli habitat rupestri”.
Il finanziamento totale è stato di 40 mila euro di cui solo 1.500 per la realizzazione di un murales.
Il disciplinare, ovvero le regole di realizzazione del progetto con Regione Puglia che fissavano la scadenza della realizzazione delle opere entro il 13 dicembre 2021 e la completa operatività entro il 10 febbraio 2022, è stato firmato il 14 giugno 2021 dalla scorsa amministrazione.
Nel progetto presentato era prevista, e citiamo, “la realizzazione di un murales sul muro dell’edificio comunale della frazione di Noha in cui sarà rappresentato un albero, con l’obiettivo di ricreare una sorta di portale ideale per richiamare l’antica credenza secondo cui il territorio di Galatina sarebbe stato un’area “protetta” dagli effetti del morso della taranta; un’area a cui dovevano accedere le “Tarantate” esterne per ritrovare la pace grazie all’acqua del pozzo di San Paolo e ai riti di espiazione e guarigione legati al tarantismo”. L’artista Frank Lucignolo è un noto e apprezzato artista internazionale ed ha voluto, nel suo murales, legare gli elementi del tema del progetto: il “Ceppo mistico”, e quindi l’albero, il tarantismo e il Pozzo di San Paolo.
Ha inserito quindi le piante di tabacco, la mietitura del grano, il carretto su cui veniva trasportato il grano e le tarantate, il Pozzo di San Paolo che guariva le “pizzicate” adottando uno stile illustrativo e di taglio fumettistico affinché attraverso la semplicità del disegno si potesse esprimere una voluta accessibilità del linguaggio.
Finita la ricostruzione, con una evidente necessità di sintetizzare, non possiamo che deprecare questo modello di opposizione, che non comprendiamo. Delle due, una: o non conoscono di ciò cui parlano o, pur conoscendola, manipolano le informazioni per assoluta mancanza di contenuti.
Insomma, nonostante questa amministrazione abbia recuperato un loro progetto prima che fosse revocato e realizzato un’opera seguendo le indicazioni da loro inserite nello stesso, hanno avuto il coraggio di trascorre intere settimane a consumare fiumi di inchiostro contro le loro stesse scelte, scomodando principi di identità territoriale (come se Noha e Galatina fossero due contrade in guerra) e addirittura il sessismo.
A noi è toccato il mesto compito di ricostruire l’ennesima procedura zoppa e di rispondere a argomentazioni al limite del grottesco. AI cittadini spetta il compito di trarne le conseguenti valutazioni, o lo hanno già fatto a giugno del 2022…
Carmine Perrone
mar202023

Si è concluso giovedì 16 marzo il progetto educativo “La sigaretta non ci dona”, organizzato dalla LILT di Lecce e rivolto ad alcune classi seconde dell’Istituto per la prevenzione del tabagismo, con un incontro coi ragazzi, presso l’auditorium della scuola secondaria di Collemeto, alla presenza della Dirigente scolastica Luisa Cascione, dottor Giuseppe Serravezza, responsabile scientifico LILT Lecce e oncologo, Valeria Calabrese, segreteria e coordinamento LILT, Diletta Potì, psicologa, Camilla Palombini, assessore alla pubblica istruzione del comune di Galatina.
Supporto fondamentale è stato il percorso formativo coadiuvato dagli esperti, oncologi, psicologi e biologi, accompagnati da Michele Perrone, volontario LILT di Collemeto, che ha portato la sua testimonianza di impegno civico e sostegno alla missione della Lega contro i tumori sul territorio provinciale.
Attraverso degli incontri e l’organizzazione di diverse tipologie di attività a cura degli esperti (psicologi, biologi nutrizionisti e oncologi) sono stati raccontati a docenti e ragazzi quali sono i danni che provoca il fumo di sigaretta e quali sono i benefici per la salute di una vita senza sigaretta.
Un impegno che si conferma sempre più necessario, anche alla luce degli ultimi dati diffusi dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), secondo cui i fumatori sono in aumento in Italia e sono, purtroppo, sempre più giovani.
Un dato che sconforta e desta preoccupazione, rispetto al quale è urgente e necessario attivare azioni di prevenzione a partire dalle scuole.
Obiettivo principale del progetto è stato, infatti, proprio quello di sensibilizzare e responsabilizzare ragazzi e ragazze rispetto ai danni provocati dalle sigarette, ma anche dai nuovi prodotti cosiddetti “light”, che l’OMS ha già bollato come pericolosi per la Salute, e sui benefici di una vita senza fumo, per far sì che sempre meno giovani accendano la prima sigaretta.
La nostra scuola ha agito, quindi, nella consapevolezza che la vera lotta al cancro debba essere combattuta fuori dagli ospedali, partendo proprio dagli alunni nelle scuole, attraverso incontri, campagne di sensibilizzazione sugli stili di vita e progetti di educazione tra pari e nella consapevolezza che non sia più rinviabile un’azione strategica di prevenzione del fumo tra i giovani, al fine di tutelare la loro Salute.
Fiorella Mastria
Vignette
Categorie News
- "Il Vangelo della Domenica" di don Francesco Coluccia (8)
- 150 anni Unità di Italia (4)
- Affresco misterioso (4)
- Ambiente (2)
- Animazioni (3)
- ASD Noha Calcio (24)
- Brividi d'estate (1)
- Campo Sportivo (6)
- Canile (3)
- Casa Betania (7)
- CDR (15)
- Cimitero (11)
- Circonvallazione (4)
- Compostaggio (3)
- Comunicato Stampa (3300)
- Concerto di Capodanno (5)
- Creatività (2)
- Cronaca (51)
- CronoNoha (3)
- Cultura (18)
- Curiosità (1)
- don Donato Mellone (21)
- doniAMO aiutiAMO vinciAMO (2)
- Equestrian Show (35)
- Eventi (197)
- Ex edificio scolastico (50)
- Festa dei Lettori (8)
- Festa Dei Salentini Nel Mondo (8)
- Fetta di Mellone (85)
- Fidas (40)
- Finibus Terrae (2)
- Fotovoltaico (35)
- Grafite è Musica (7)
- I Beni Culturali (37)
- I Dialoghi di Noha (27)
- Il Mangialibri (5)
- In memoria di (3)
- Ipogeo (3)
- Istituto Comprensivo Polo 2 (30)
- Itinerario turistico (1)
- La chiesa di Noha e i Vescovi di Nardò (22)
- La Storia (6)
- La Via Crucis vivente (8)
- La videodenuncia (4)
- Lauree (3)
- Le Confraternite di Noha (8)
- Lettere (12)
- Lettere al direttore (10)
- Letture estive (15)
- Levèra (7)
- Libro di Noha (11)
- L'Osservatore Nohano (52)
- Mini Medical School (4)
- MSGradio (2)
- Mundialito Cup (1)
- Musicando pensieri (5)
- Necrologi (90)
- No alla Discarica (2)
- Noha Street View (1)
- NohaBlog (748)
- NohInondazioni (4)
- NoiAmbiente (95)
- Note a Margine (3)
- Nucleare (3)
- Ordinanze e Decreti (1)
- PhotoGallery (102)
- Piedibus (5)
- Politica (29)
- Presepe Vivente (184)
- Primaria Noha (2)
- Racconti (15)
- RadioInOndAzioni (23)
- Recensione libro (22)
- Referendum (12)
- Regione Salento (1)
- S.Maria della Porta (3)
- Sant'Antonio (3)
- Scritti in onore di... (4)
- Storie dal Salento (13)
- TeleNoha (84)
- Un'altra chiesa (72)
Catalogati per mese:
Ultimi commenti:
-
Cercare, di inglobar...
26/03/2025 @ 08:54:43
Di Salvio
-
Stake Online Casino ...
22/03/2025 @ 06:23:19
Di gameathlon.gr-Dap
-
The Stake Casino gam...
21/03/2025 @ 14:05:50
Di gameathlon.gr-Dap
-
Stake Casino gameath...
20/03/2025 @ 06:20:20
Di gameathlon.gr-Dap
-
....ciao Piero, ciao...
12/03/2025 @ 12:49:26
Di S.Cito
Categorie Video
- 4 novembre (1)
- Anniversario di Sacerdozio (2)
- Barocco Talent (1)
- C.D.R. (7)
- Carnevale (1)
- Casa Betania (2)
- Casiceddhre (4)
- Cavalli Noha...la Favola (7)
- Centro Aperto Polivalente (10)
- Cronaca (1)
- Equestrian Show (16)
- Festa dei Lettori (7)
- Festa di S. Michele Arcangelo (14)
- Fette di mellone (5)
- Fiera dei Cavalli (Madonna delle Grazie) (6)
- Fiera dei Cavalli (Madonna di Costantinopoli) (13)
- Fotovoltaico (21)
- Gara Ciclistica (1)
- Giornata Ecologica (1)
- Gli Ulivi (2)
- Grafite è Musica (1)
- I Beni Culturali (8)
- I Dialighi di Noha (5)
- I Talenti (2)
- Il Mangialibri (9)
- Ipogeo (2)
- La Banda (2)
- La Casa Rossa (2)
- La Cuccagna (3)
- La Curemma (5)
- La Sapienza criterio di Dio (7)
- La Vendemmia (1)
- La Via Crucis vivente (4)
- La videodenuncia (4)
- Le Palme (2)
- Lu Santu Lazzaru (1)
- Maniscalco (2)
- Motoraduno Moto Guzzi (11)
- Phisica (1)
- Presentazioni (4)
- Presepe Vivente (103)
- Primavera LIBERA tutti (7)
- Radioinondazioni (13)
- Salvatore Borsellino (1)
- Scrigno dei Ricordi (2)
- Scuola (2)
- Tabacco (1)
- Tarante (1)
- Vari (24)
Salento
Sondaggi
Info
Quanti siamo
Link Siti Amici
Seguici sui Canali di
 |
 |
 |
 |
Calendario
Meteo

La Raccolta Differenziata
News dal Salento
- Lecceprima
- TR News
- Il Paesenuovo
- Il Gallo
- Corriere Salentino
- SalentoPocket
- Il Taccoditalia
- LecceNews24








